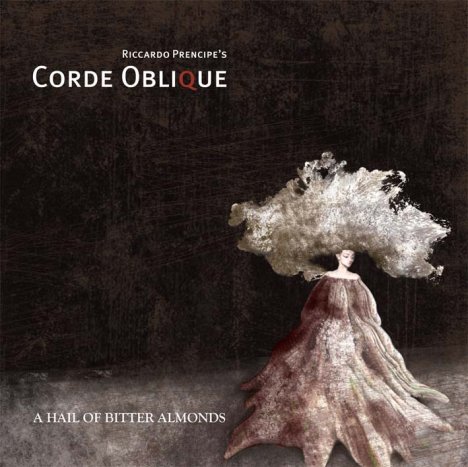(Ticker Tape, 2011)






Quante band possono permettersi di annunciare l’uscita di un nuovo album con soli quattro giorni di anticipo e con un semplice “Thank you for waiting” sul proprio blog, senza nessun’altra pubblicità, quasi a non voler fare rumore, da consumate anti-star? Quante band, nonostante questo, rendono l’uscita di ogni album un evento, un momento in cui chi fa musica (magari cercando di dire qualcosa di nuovo) e chi ne scrive è costretto a resettare molti parametri e a ridefinire in qualche modo il concetto di “nuovo”? Quante band ad ogni nuovo album hanno il coraggio di rigenerarsi, scrivendo musica apparentemente senza nessun legame con quanto fatto in precedenza, e che costringe chi ascolta a fermarsi e ad assaporare il disco più volte per entrarvi appieno e a interrogarsi profondamente su cosa quella musica ha da dire? Tutte queste domande hanno la stessa risposta: molto poche, e in cima alla lista ci sono sicuramente i Radiohead.
Messa da parte la politica dell’“it’s up to you”, che permetteva a chi comprava il loro precedente album “In Rainbows” (del 2007) di stabilire il prezzo da pagare per il download della versione digitale (o scegliere un discbox in edizione limitata), il quintetto di Oxford continua a rinunciare alle vie tradizionali del mercato discografico: la distribuzione di questo nuovo “The King Of Limbs” avviene semplicemente tramite il sito thekingoflimbs.com, dove si può scegliere tra il formato digitale (disponibile dal 18 febbraio, stavolta ad un prezzo fissato) e una speciale edizione “newspaper” (le cui spedizioni sono iniziate il 28 aprile). Edizioni più regolari in cd e in vinile sono state realizzate dalla indipendente XL Recordings (che aveva pubblicato analoghe edizioni anche di “In Rainbows”).
E proprio dal magnifico artwork creato come sempre da Stanley Donwood (al fianco della band dai tempi di The Bends) e da Thom Yorke si cominciano a intravedere le differenze con il lavoro precedente: il discbox di “In Rainbows” è un oggetto molto grande e pesante (Donwood dice ironicamente: “volendo farlo, potresti usarlo per uccidere qualcuno!”), e che voleva rappresentare uno “statement definitivo” sullo stato della band. L’idea alla base di “The King Of Limbs” era, al contrario, quella di creare “qualcosa che quasi non esistesse”, di sfuggente, che potesse testimoniare come il momento musicale dei Radiohead sia transitorio. Da qui l’idea del “newspaper album”: Donwood, che lavora negli stessi luoghi e negli stessi momenti in cui la band compone la musica (ha addirittura dichiarato di non aver ascoltato la versione definitiva dell’album prima di riceverla per posta come un fan qualunque!), permettendo così all’artwork e alle canzoni di nutrirsi reciprocamente, spiega che “quando un giornale viene pubblicato non significa che le notizie si fermino, e quello che hai è solo un’istantanea di come stanno le cose nel momento in cui il giornale è stato stampato. Nello stesso modo questo album mostra dov’erano i Radiohead nel momento in cui è stato pubblicato. La musica è un continuo divenire, e volevamo che l’album rappresentasse questa idea.”.
E dunque a che punto è il continuo divenire dei Radiohead secondo “The King of Limbs”? L’artwork rende in parte l’idea: due 10” in splendido vinile trasparente, conservati in eleganti involucri decorati con disegni di alberi antichi (“The King Of Limbs” prende il nome da un’antichissima quercia situata nella contea del Wiltshire, a ovest di Londra) e misteriosi fantasmi colorati; un cd in una semplicissima, quasi squallida, custodia di cartone (a testimoniare la convinzione che il cd come supporto per la musica non ha più alcuna importanza, né tantomeno alcun valore estetico); il bellissimo giornale contenente altri disegni di alberi e fantasmi, dipinti astratti, versi dalle canzoni e testi di varia natura, note di copertina, foto della band; un curioso foglio fatto di 625 quadratini di carta assorbente decorati, simili a quelli che si usano per assumere LSD. Il tutto è tenuto insieme da un involucro di plastica biodegradabile, e in generale tutti i materiali di cui è fatto l’artwork sono stati accuratamente scelti in modo da degradare abbastanza rapidamente e con il minimo impatto ambientale. Queste scelte, oltre a mostrare ancora una volta l’attenzione dei Radiohead alle tematiche ambientali (nel caso di Thom Yorke è quasi un’ossessione), vorrebbero probabilmente dare l’idea di una musica che crea ambientazioni eteree, volatili, impalpabili, persino effimere (naturalmente non nello stesso modo in cui è effimera e impalpabile una hit da classifica, ça va sans dire). Ed è questa l’impressione che coglie chi si avventura nel primo ascolto: brani semplici, scarni, fatti di sensazioni placide e di consapevole serenità d’animo, e costruiti su pochi suoni delicati, come se la band fosse in realtà un unico strumento più la voce immortale di Thom Yorke.
Ma poi arriva il momento del secondo ascolto, e di quelli successivi: i suoni diventano tantissimi e quello che sembrava un solo strumento comincia a schiudersi e a rivelarsi come una band, la band, e a mostrare le sue sfaccettature. E allora ecco i loop spezzati e le percussioni di “Bloom”, fatta di una continua sovrapposizione di campionamenti di tutti gli strumenti e di una stupenda linea vocale che segue placide onde, e impreziosita da uno straordinario lavoro di basso e dagli interventi delle tastiere e di un flicorno; o i ritmi frenetici ed elettrizzati e l’ossessiva chitarra stoppata di “Morning Mr. Magpie”, in cui non si fa fatica ad immaginare Thom Yorke alle prese con una delle sue danze impazzite. E a proposito di danze andate a vedere il video di “Lotus Flower”, diretto da Garth Jennings, già regista del bellissimo video di “Nude” (da “In Rainbows”), di alcuni dei videoclip più geniali dell’ultimo decennio o poco più (basta citare “Pumping on Your Stereo” dei Supergrass, “Coffee & TV” dei Blur, “Imitation of Life” dei R.E.M. e soprattutto “Right Here, Right Now” di Fatboy Slim), oltre che del film “Guida Galattica per Autostoppisti”: cinque minuti di follia danzante con una punta di autoironia a descrivere uno dei brani più riusciti dell’album, fatto di tappeti di synth, basso pulsante, batteria secca e semplice, le chitarre a colorare e a dare le sfumature e una linea vocale che cattura al primo ascolto.
Le chitarre la fanno da padrone in senso più classico, invece, in “Little by Little”, con un giro di accordi circolare sostenuto da molte percussioni, mentre in “Feral” vengono deformate e utilizzate per dipingere assieme alla voce, che in questo caso fa da semplice colore aggiuntivo, un ambiente ipnotico, stralunato e un po’ sinistro, costruito su un loop di bassi profondi e percussioni convulse, ancora una volta molto invitante da ballare.
“Codex” e “Give Up the Ghost” cambiano completamente registro: sono due ballate dolci, delicate, un po’ malinconiche, la prima suonata al piano e con bellissimi interventi degli ottoni a sostenere la linea vocale, la seconda fatta di accordi semplici alla chitarra acustica, un’elettrica pulita in fingerpicking e tanti mantra vocali che si sciolgono l’uno dentro l’altro, una goccia alla volta, fino a creare uno struggente mare di voci sognanti. Da notare che entrambi i brani sono accompagnati da un battito profondo e continuo, come quello di un cuore, quasi a testimoniare che questi sono i brani più emotivi dell’album. Chiude il disco (forse un po’ in fretta: la durata complessiva non arriva a 38 minuti) “Separator”, che mostra ispirazioni vicine al krautrock e si esalta in una linea vocale molto serena e nella solita splendida stratificazione delle chitarre.
Non sappiamo come alla prova del tempo questo disco reggerà il confronto con gli altri (capo)lavori dei Radiohead, ma di certo questo “The King of Limbs” (prodotto ancora una volta da Nigel Godrich, dietro le quinte del Radiohead sound dal 1994, tanto che spesso viene definito il sesto membro della band, un po’ come era George Martin per i Beatles) è un lavoro che mantiene la loro discografia a livelli altissimi e per questo non può passare inosservato. Diverso da tutti i precedenti, l’album mostra un’ulteriore evoluzione del quintetto sia dal punto di vista sonoro che da quello compositivo e restituisce una band che forse mai come in questo caso riesce a diventare un’entità unitaria e superiore, pur non nascondendo le individualità dei musicisti: semplice, preciso ed efficace Phil Selway alla batteria; presente e creativo come non mai Colin Greenwood al basso; Ed O’Brien alla chitarra, ispirato e mai invadente, si occupa di quei piccoli dettagli sonori che spesso fanno la differenza, mentre Jonny Greenwood si divide fra chitarra, sintetizzatori e campionatori vari, incarnando la componente sonora più importante della band, ma senza mai peccare di protagonismo; inarrivabile, infine, Thom Yorke: cantante inimitabile, ha una voce mozzafiato, sempre più leader ma mai egocentrico, porta sulle spalle tutto il carico emozionale del gruppo dimostrandosi per l’ennesima volta l’inestimabile valore aggiunto alla già sopraffina qualità della musica. Insomma i Radiohead aggiungono un altro tassello importante al loro straordinario e coerente percorso artistico, sempre lontano dalle tendenze e dalle logiche del mercato, e sempre teso a esplorare nuovi mondi musicali.
Recensione di Andrea Carletti