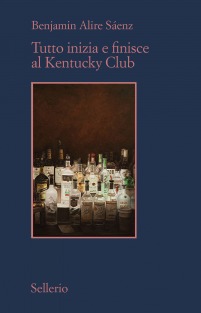Michel Bussi. Ninfee nere. Edizioni e/o, 2016. 400 pag. 16 euro
Traduzione: Alberto Bracci Testasecca





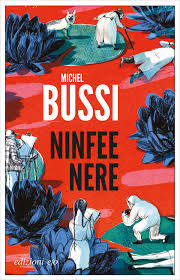 E’ difficile dare un parere sull’interezza di questo romanzo pluripremiato in patria e molto apprezzato anche dai lettori. Quel che rimane in bocca dopo avere terminato l’ultima pagina è un sapore non gradevolissimo che però non è percepito durante la lettura, fino a poche decine di pagine dalla fine. Sostanzialmente, sempre alla fine, quando tutti i nodi della trama sono dipanati, si ha l’impressione (ma sarebbe meglio dire la ferma convinzione) che l’autore abbia voluto fare il furbetto e abbia volutamente fatto cadere il lettore in trappole grossolane, in cui è caduto soltanto per una mancanza di informazioni, non perché sia tonto.
E’ difficile dare un parere sull’interezza di questo romanzo pluripremiato in patria e molto apprezzato anche dai lettori. Quel che rimane in bocca dopo avere terminato l’ultima pagina è un sapore non gradevolissimo che però non è percepito durante la lettura, fino a poche decine di pagine dalla fine. Sostanzialmente, sempre alla fine, quando tutti i nodi della trama sono dipanati, si ha l’impressione (ma sarebbe meglio dire la ferma convinzione) che l’autore abbia voluto fare il furbetto e abbia volutamente fatto cadere il lettore in trappole grossolane, in cui è caduto soltanto per una mancanza di informazioni, non perché sia tonto.
Giocare con il tempo, confondendo e sovrapponendo i diversi tempi narrativi della vicenda e per giunta cambiando i nomi dei personaggi a seconda del periodo di cui si sta narrando, è un gioco che sta in piedi fino a quando non viene svelato. A quel punto si possono avere due reazioni.
La prima, se si ha scarsa autostima di sé come lettore (e forse anche come persona intellettivamente dotata, diciamo con un Q.I. che arrivi almeno a 120-130) è quella di dire/pensare: “che bravo quest’autore, mi ha fatto girare in un labirinto di specchi e non me ne sono minimamente reso conto…”. L’altra, probabilmente quella di lettori più evoluti o smaliziati (o con un Q.I. più robusto) porta a dire/pensare. “ Ma che me sta’ a pigghià po ‘o culo?”.
Certo, non è elegante, ma posso giurare che viene davvero spontaneo.
Nelle ultime pagine, quasi potessi leggere tra una riga e l’altra, vedevo alcune frasi del testo di Stephen King sul suo modo di intendere la scrittura di una storia, il famoso “On writing” (Sperling & Kupfer, 2000). Per umana pietà non le starò ad elencare, citerò soltanto la più ricorrente.
Niente trucchetti!
E invece questo testo è solo un grande, colossale, ingiustificato trucchetto.
A parte alcune cadute di stile di cui neppure Liala sarebbe stata orgogliosa, si fa leggere senza difficoltà, in particolar modo per l’affascinante ambientazione a Giverny, nel centro francese in cui visse e operò per decenni Monet, le incursioni sul suo percorso artistico e per le caustiche riflessioni sul turismo culturale, ma purtroppo non ha nessuna giustificazione sperimentale, culturale o provocatoria per permettersi di prenderci in giro per centinaia di pagine.
Se quel che si vuole avere da un romanzo è bieco intrattenimento può anche anche andar bene, ma il finale ha lo stesso effetto di una legnata sulle balle e, ribadisco, non è per niente gradevole.
Non so, è palese quanto ormai l’industria editoriale (soprattutto quella italiana) stenti a sopravvivere e abbia bandito dai mezzi di comunicazione destinati ad un grande numero di persone qualsiasi parola che non sia elogiativa o neutra, ma spacciando questo romanzo per un capolavoro si può rischiare di essere incriminati per falso in atto pubblico.
recensione di Daniele Borghi