Nicola Lagioia, La ferocia Einaudi, 2014. 411 pag. 19.50 euro
Premio Strega 2015. Senza rating
 Nella lingua italiana, volendo dar credito al vocabolario Treccani, che come fonte mi pare piuttosto attendibile, l’aggettivo “sofisticato” ha due accezioni quasi opposte. L’accezione che ha valenza negativa ha sinonimi che possono essere: adulterato, alterato, manipolato, affettato, artefatto, artificioso, innaturale, complicato e lambiccato. L’accezione con valenza positiva, invece, può avere per sinonimi: raffinato, ricercato, avanzato, perfezionato.
Nella lingua italiana, volendo dar credito al vocabolario Treccani, che come fonte mi pare piuttosto attendibile, l’aggettivo “sofisticato” ha due accezioni quasi opposte. L’accezione che ha valenza negativa ha sinonimi che possono essere: adulterato, alterato, manipolato, affettato, artefatto, artificioso, innaturale, complicato e lambiccato. L’accezione con valenza positiva, invece, può avere per sinonimi: raffinato, ricercato, avanzato, perfezionato.
La nettissima sensazione che si ha leggendo questo romanzo è che l’autore abbia inseguito l’accezione positiva, la seconda, e sia invece – e purtroppo per il lettore- paurosamente precipitato nella prima. Su ogni frase il lavoro è ossessivo, ma questo stesso lavoro, risulta evidente ad un lettore appena smaliziato e di conseguenza contagia e infetta la scrittura con la stessa virulenza di un Ebola letterario. La scrittura dell’intero romanzo, a seguito di quest’infezione, rimane vittima della intenzioni dell’autore. Detto in altre parole il succo è questo: la narrazione viene annientata dall’ossessività con cui l’autore, certamente con la potente complicità del suo editor di riferimento, ha lavorato su questo testo. Non per cavarne il meglio, obiettivo di ogni attività di editing, ma per la ricerca di un ipotetico “bello scrivere” o, ancor peggio, di uno “stile” che ha massacrato un’idea di partenza che avrebbe potuto essere sviluppata in modo interessante.
Allo scopo di essere meno vago, di seguito riporto alcune frasi che mi sembrano un buon modo per rendere più chiaro quel che sto scrivendo. Secondo me siamo in quel territorio che potrebbe frequentare un Baricco sotto acido, (moltissimo acido e di cattiva qualità per essere più precisi) ma forse sbaglio.
“Giacca e pantaloni ricadevano nel facsimile dell’eleganza, un volontario passo indietro rispetto a quella vera ma solo per farle strada”.
“La competizione partecipa dell’amicizia, l’invidia dell’ammirazione”.
“L’adulterio non partecipa forse di abnegazione? L’omicidio di umanità e la bestemmia di una fede sofferta?”
“L’idea del sublime (ma come avere la prova che non fossero le farneticazioni di un imbecille?) andava di pari passo con l’ossessione computazionale”.
“Vestiva un casual che corteggiava la moda negandola con troppa timidezza”.
“In lontananza si levava il mormorio della città prima del risveglio, un rumore di automobili senza automobili, la piccola tempesta elettrica dei tanti che, sul punto di riaprire gli occhi, rivivevano in poche frazioni di secondo il film della giornata che stava per iniziare”.
“Ogni volta che tirava fuori i soldi per pagare il ticket alla cassiera della Asl percepiva un groviglio arroventato di filamenti neri”.
“Inviti al suicidio, insulti estemporanei che risalivano da strette verticalità”.
“La luce regredì verso i colori che il sole poteva aver avuto nel lungo sonno precambriano, prima che la vita comparisse sulla terra”.
“Che stupidi gli uomini quando erano anche intelligenti”.
“I mesi senza Clara sono una sorta di falso incubo. Come se l’incubo lo sognasse una fotocopiatrice. Il che è anche peggio”.
“Mentre fanno l’amore lei porta il piacere a sé come scuoiasse un animale”.
Naturalmente queste frasi non sono inserite in un dialogo, in quel caso sarebbe tutto diverso, sono tutte frasi che Lagioia -non mia- ha inserito in descrizioni, per nulla condizionate dalla voce di uno dei personaggi.
Oltre a queste perle, va sottolineato che tutto il testo corre su un difficile equilibrio di scelte formali, passando dalla scrittura di frasi “soggetto-verbo-complemento oggetto” (quelli che hanno studiato la chiamano scrittura paratattica) a periodi ariosi alla Proust e senza disdegnare frasi fatte e sgradevoli come “stava per andare ai matti” per descrivere una difficile situazione psicologica. L’intero romanzo è un continuo, affannoso tentativo di descrivere nascondendo, di forzosa reticenza narrativa originata dal desiderio di raggiungere un modello formale originale e di concedersi divagazioni linguistiche che umiliano l’etica delle parole.
Lagioia -sempre non mia- flirta con con il criptico, corteggia senza successo l’aforistico, accarezza contropelo il lirico e non di rado (ved. sopra) si rende facile bersaglio di scherno. E tutta questa fastidiosa ricerca formale, che in filigrana è facilissima da vedere, oltre che partorire più di 400 pagine di robaccia, trova la sua misera e ingloriosa fine, quasi un suicidio, con lo stupro di un congiuntivo (pag.157):
“Alle dieci e un quarto pensò che era il momento di fare una pausa”.
Come scrivevo prima: fa lo stesso effetto che trovare una merda fumante in un tentativo di piatto sofisticatissimo. Viene voglia di telefonare all’autore e gridargli in un orecchio:
“Fosse, Nico’, fosse. Non era”.
Magari con un forte e volgarissimo accento dialettale, non importa di dove. Servirebbe a ricordargli di provare a stare con i piedi per terra: più alti si prova a volare e più forte è il botto quando si cade.
E questo è uno di quei casi in cui la cosiddetta saggezza popolare dei proverbi non teme smentite. L’anno scorso, quando avevo letto con grande godimento “Il desiderio di essere come tutti” di Francesco Piccolo, avevo per un attimo pensato che lo Strega potesse tornare agli anni in cui venivano premiati dei veri scrittori… ho paura di essermi illuso.
Dimenticavo, visto che mi ci trovo, tanti cari saluti agli “Amici della domenica”.
Francesco Muzzopappa, Una posizione scomoda Fazi Editore, 2013. 221 pag. 14.50 euro





 Nel numero di due mesi fa, quello di luglio, ho molto elogiato l’ultimo romanzo di Dazieri, altrettanto non posso fare per le sue parole di presentazione/pubblicità pubblicate sulla copertina di questo romanzo di Muzzopappa, anzi, tutt’altro. Senza dubbio non si può affermare che il romanzo in questione sia sgradevole, ma da questo a dire che “si ride dalla prima all’ultima pagina” occorre un bel po’ di faccia tosta.
Nel numero di due mesi fa, quello di luglio, ho molto elogiato l’ultimo romanzo di Dazieri, altrettanto non posso fare per le sue parole di presentazione/pubblicità pubblicate sulla copertina di questo romanzo di Muzzopappa, anzi, tutt’altro. Senza dubbio non si può affermare che il romanzo in questione sia sgradevole, ma da questo a dire che “si ride dalla prima all’ultima pagina” occorre un bel po’ di faccia tosta.
A volte capita di sorridere, e senz’altro il brano che è riportato sulla quarta di copertina è quello più divertente (non sono mica stupidi), ma complessivamente l’intero testo è monocorde, ha un finale quasi fiabesco, poco credibile incollato con l’attaccatutto e, a dispetto della scarsa credibilità, è anche prevedibile.
Fulcro di tutto il testo è la professione del protagonista, uno sceneggiatore di film porno (vi lascio immaginare a quale livello siano le sceneggiature) ed è un continuo, ininterrotto via vai di battutine con riferimenti sessuali più o meno espliciti, titoli di film porno che fanno il verso a film “seri” e difficoltà del protagonista a far accettare o nascondere, a seconda dei casi, la sua professione.
Il guaio è che il romanzo non si cambia mai tono. L’imbarazzo causato dalla professione è descritto con lo stesso registro con cui è descritta la cerimonia di premiazione dello “Zizì d’or” (una sorta di Oscar del porno, almeno così lo definisce l’autore), le incomprensioni familiari causati sempre dalla professione sono spiattellati sulla pagina con la stessa voce con cui, in altri passaggi, si raccontano le improbabili sceneggiature di film come “Ventimila seghe sotto i mari”, e giuro che questo è il titolo più “casto”. Oppure la descrizione del produttore/produttore (un trans) ha lo stesso passo della descrizione dei genitori del protagonista. Non si avverte mai un cambio di marcia e se, come ho già scritto, il romanzo non è sgradevole, la tensione narrativa si allenta con lo scorrere delle pagine fino a diventare una sorta di prevedibile poltiglia. In alcuni passaggi sembra che l’autore abbia voluto tirar fuori un romanzo da un racconto, allungando il brodo con una serie di brani del tutto inutili e in altri, ad esempio l’intera lavorazione del suo primo film “serio”, abbia trascurato di approfondire negando al lettore di conoscere l’esperienza che fa cambiare prospettiva al protagonista. Di fatto si passa dalla firma del contratto alle recensioni, tra l’altro negative in modo non credibile.
In sintesi una prova non convincente ma che non prevede bocciatura per le intenzioni stesse del romanzo che non voleva essere scolpito negli annali della letteratura ma solo intrattenere: non ci è riuscito bene ma non è detto che la prossima volta Muzzopappa possa fare meglio.
Fred Vargas, Tempi glaciali Einaudi, 2015. 442 pag. 20 euro
Traduzione: Margherita Botto.





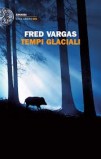 Pochissimi scrittori contemporanei hanno la grazia di Fred Vargas e ancor meno sanno farne un uso discreto, al completo servizio della vicenda narrata. Questo basterebbe a chiudere qui il mio commento a questo romanzo, ma preferisco essere meno lapidario e articolare maggiormente i concetti che originano questa mia affermazione.
Pochissimi scrittori contemporanei hanno la grazia di Fred Vargas e ancor meno sanno farne un uso discreto, al completo servizio della vicenda narrata. Questo basterebbe a chiudere qui il mio commento a questo romanzo, ma preferisco essere meno lapidario e articolare maggiormente i concetti che originano questa mia affermazione.
Vargas ha il grande dono di scrivere come penserebbero i suoi personaggi e questo rende i suoi romanzi una sorta di esperienza al quadrato. Pur ricorrendo ad un apparentemente banale narrazione in terza persona, l’autrice scrive con lo stesso distacco svagato di molti dei suoi personaggi, senza mai dimenticare di avere in mano le redini del racconto, ma facendo fare ad esso dei percorsi complessi, come complessi e originali sono i percorsi mentali degli abitanti di questo testo, in particolar modo del protagonista, il commissario Adamsberg.
Il soprannome che il personale del distretto ha affibbiato al commissario (“lo spalatore di nuvole”) dice molto più di qualsiasi altra complessa e lunga dissertazione sulle caratteristiche del protagonista principale, esattamente nello stesso modo in cui alcuni brevi brani di precisione chirurgica illuminano vicenda e personaggi del romanzo. Anche le vicende narrate hanno particolari caratteristiche di complessità, ma al contempo sono chiaramente intellegibili e, soprattutto, godibili.
In questo particolare caso, le motivazioni dei delitti che punteggiano la vicenda e le complicazioni nel dipanarsi dell’indagine, risalgono nientemeno che alla Rivoluzione Francese: soltanto Vargas con il suo “spalatore di nuvole” poteva rendere credibile una tale acrobazia.
Occorrerebbero molte pagine per rendere giustizia a Vargas e a questo romanzo che, pur potendosi definire un “polar” (neologismo orrendo coniato dai francesi per sintetizzare le parole “poliziesco” e “noir”) ha al suo interno molto più di un semplice abbinamento di generi peraltro già molto vicini tra loro. D’altro canto chi ascolta rock conosce benissimo il vecchio ma sempre attuale detto che recita: “The singer, not the song”.
Per chi è a zero con l’inglese, fascia di popolazione sempre più trascurata e vessata da giornalisti idioti, traduco: “Il cantante, non la canzone”. E Vargas ha davvero una gran bella voce.
Phil Klay, Fine Missione. Einaudi, 2015. 247 pag. 19 euro.
Traduzione: Silvia Pareschi





 E’ difficile non entusiasmarsi di fronte ad un testo così potente. In dodici racconti l’autore ci scaraventa dentro le molte e diverse conseguenze della guerra, rendendole dolorosamente vere in modo esemplare, come di rado capita di leggere.
E’ difficile non entusiasmarsi di fronte ad un testo così potente. In dodici racconti l’autore ci scaraventa dentro le molte e diverse conseguenze della guerra, rendendole dolorosamente vere in modo esemplare, come di rado capita di leggere.
L’unità tematica che contraddistingue questa raccolta potrebbe spingere a dire che questo testo sia un romanzo dalla struttura articolata in racconti, il romanzo sulla guerra in Afghanistan e Iraq. In ogni racconto, anche quando non se ne parla direttamente, con il suo immane peso, la guerra pervade ogni riga e ogni pagina come un mantello nero con piccolissimi squarci che, pur non facendo intravedere nessuna luce, ne lasciano un minimo di speranza. La cristallina bellezza di questo testo risiede innanzitutto nell’asciuttezza della scrittura, ma non secondaria, anzi direi decisiva è la molteplicità dei punti di vista. I dodici racconti esplorano con folgorante dignità e profonda, sentita partecipazione, ogni dolore della guerra e ogni sua demente manifestazione. Dal cappellano che non sa dare risposte a chi lo interroga sul senso di essa a chi ne è uscito con ferite orrende e completamente sfigurato. Dall’ingenuo e indottrinato marine che si domanda quante morti avrà procurato con il suo pezzo di artiglieria e se può andarne orgoglioso all’altrettanto smarrito marine che cerca di spiegare ad una sua compagna di college i motivi che lo hanno spinto ad arruolarsi. La burocrazia dell’esercito viene descritta con pagine che ricordano quelle di Joseph Heller in “Comma 22” ma fanno un deciso passo avanti negandone il lato grottesco e, a dimostrazione di quanto in questi ultimi decenni lo spirito critico e antiautoritario sia disgregato e sepolto, i personaggi che ne subiscono le ingiurie si adattano ad essa, si plasmano sui controsensi e si adagiano sulle procedure. In ogni pagina del testo non c’è una sola parola di ribellione, soltanto rassegnazione, disagio e dolore. E’ facile immaginare che, a differenza della seconda guerra mondiale, essendo queste guerre combattute da volontari, l’atteggiamento sia pratico che psicologico dei soldati debba essere diverso, ma non credo che questo sia sufficiente ad anestetizzare completamente un essere umano.
Diretto, privo di qualsiasi sofisticazione visibile, vocabolario scarno ai limiti della basicità, molteplicità di punti di vista, sintesi perfetta che non trascura nulla ma lo rende soltanto estremamente efficace, “Fine Missione” è un mosaico magnificamente compiuto, in cui ogni tessera si accoppia con alla perfezione con quelle attorno e da vita ad una immagine che non ne è solo la somma ma la moltiplicazione.
J.R. Moehringer, Il campione è tornato Piemme, 2015. 80 pag. 14 euro
Traduzione: Annalisa Carena





 Dopo alcuni testi di oggettiva grande potenza narrativa (due su tutte “Open” con/per Andrè Agassi e “Il bar delle grandi speranze”, intenso romanzo di formazione come da tempo non se ne leggevano) Moehringher è ora in libreria con una pubblicazione dal formato editoriale del romanzo ma che ben poco a che vedere con questo tipo di testo. Innanzitutto l’estensione è ridottissima, 80 pagine stampate con un carattere adatto agli ipovedenti, ma ciò che non si riesce a capire è soprattutto la sostanza, la ragion d’essere di questo testo a metà tra l’introspezione e l’indagine alla ricerca di qualcosa che, a livello non superficiale, non si capisce esattamente cosa sia. L’autore, in alcuni passi, sembra provare a scusarsene adducendo motivazioni sghembe, trasversali, come la ricerca del padre che ha pochissimo conosciuto, la passione per la boxe, per i “magnifici perdenti” o per la ricerca della virilità, ma tutte queste tematiche sono appena sfiorate.
Dopo alcuni testi di oggettiva grande potenza narrativa (due su tutte “Open” con/per Andrè Agassi e “Il bar delle grandi speranze”, intenso romanzo di formazione come da tempo non se ne leggevano) Moehringher è ora in libreria con una pubblicazione dal formato editoriale del romanzo ma che ben poco a che vedere con questo tipo di testo. Innanzitutto l’estensione è ridottissima, 80 pagine stampate con un carattere adatto agli ipovedenti, ma ciò che non si riesce a capire è soprattutto la sostanza, la ragion d’essere di questo testo a metà tra l’introspezione e l’indagine alla ricerca di qualcosa che, a livello non superficiale, non si capisce esattamente cosa sia. L’autore, in alcuni passi, sembra provare a scusarsene adducendo motivazioni sghembe, trasversali, come la ricerca del padre che ha pochissimo conosciuto, la passione per la boxe, per i “magnifici perdenti” o per la ricerca della virilità, ma tutte queste tematiche sono appena sfiorate.
E’ ovvio che in un’ora di lettura, il testo non regala di più, la possibilità di affrontare questi temi a dir poco smisurati ( e di cui, tra l’altro, almeno un paio erano già stati lungamente trattati ne “Il bar delle grandi speranze”) è negata in partenza… ma allora perché iniziare? Tutto questo ha l’aria di una bieca operazione editoriale per battere il “ferro” Moehringer finché è caldo, da l’impressione di un testo incompleto e appena abbozzato tirato fuori da un cassetto per mandare qualcosa in tipografia e l’impressione è ampiamente suffragata dal fatto che questo libro sia sostanzialmente l’unione di tre lunghi articoli scritti da Moehringer molti anni fa, quasi venti, e da cui fu tratta anche una sceneggiatura e da essa un film. Naturalmente la scrittura è di grande livello, il talento narrativo dell’autore non è neppure vagamente messo in discussione, ma stavolta Moehringer non ha avuto nulla a supportarli. Anche i brani meglio riusciti, e se ne trovano almeno tre di grande qualità, tendono a sciupare il loro splendore perché inseriti in una struttura indebolita in partenza da motivazioni non potenti o non illustrate a sufficienza. Per ridurre tutto ad una estrema sintesi si può dire che “Il campione è tornato” è una buona occasione persa. Se innervato, ampliato e articolato meglio, grazie al talento dell’autore e alle potenzialità della vicenda narrata, sarebbe stato sicuramente un ottimo romanzo. Purtroppo non è andata così, se per fretta di pubblicare, per motivi contrattuali o semplicemente per valutazioni sbagliate… non lo sapremo mai. Quel che è certo è che ora in libreria c’è questa cosa stramba che non è un romanzo, non è un saggio, non è un lunghissimo articolo e non aggiunge nulla alla grande tradizione americana dei testi sull’epica della boxe. A proposito: se volete leggere qualcosa su quest’argomento andatevi a cercare una vecchia raccolta di racconti di Thom Jones. La casa editrice è Minimum Fax ed il titolo è “Sonny Liston era mio amico”. Lì troverete il sapore di un Hemingway distillato e invecchiato in botti di rovere e la luce livida e impietosa di “Fat City” di John Huston: un capolavoro.
rubrica a cura di Daniele Borghi


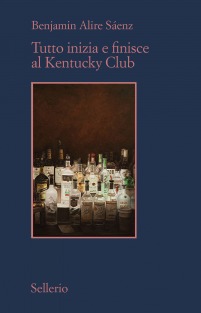


E’ davvero un bel blog, complimenti Daniele.
Buon giorno, ho seguito l’analisi del romanzo di LA GIOIA, e da un lato penso che certe ambizioni letterarie diano una fustata d’energia all’intero discorso.
Ma ritengo che la tecnica di sparare fuochi d’artificio iperbolici a suon di abbaglianti metafore debba essere ancora perfezionata perché, se si sta attenti alla lettura, si incappa in ripetizioni abbastanza illogiche.
Comunque è un piacere assistere ai fumi colorati e alle fiammate della narrazione di LA GIOIA; se non sentiamo odor di zolfo ogni dieci o venti righe, tutto è solo ben fatto e annoia, non mette brividi. E senza brividi alla fine si dorme.
Concludo mettendomi in mezzo, come si dice, e siccome ho un romanzo su Amazon intitolato IL POTERE SUI MORTI che svolge una sorta di doppia trama legata alla travagliata degenerazione di una amicizia, CHIEDO UMILMENTE di essere recensito perché sia io che il mio romanzo ne sentono il bisogno.
Siamo due crisantemi che vogliono il rugiadoso commento di un raggio di sole critico…
A PRESTO ALBERTO FAREGNA, SCRITTORE E ARTISTA DI STRADA, ATTORE, CIAO.