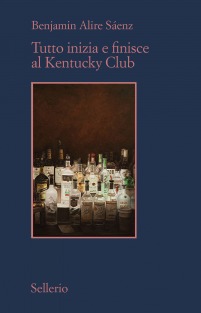Mordecai Richler, La storia di Mortimer Griffin Adelphi, 2015 (1968). 242 pag. 18 euro
Traduzione: Giovanni Ferrara degli Uberti





 Anche se del tutto normale e prevedibile, è impressionante notare quanto la scrittura di questo romanzo sia lontana da quella de “La versione di Barney”, probabilmente l’opera più matura e meglio riuscita di Richler.
Anche se del tutto normale e prevedibile, è impressionante notare quanto la scrittura di questo romanzo sia lontana da quella de “La versione di Barney”, probabilmente l’opera più matura e meglio riuscita di Richler.
Scritti a più di trent’anni di distanza, vedono tracimare tra le loro pagine la ridondante personalità del loro autore e, per inevitabile osmosi, ne sottolineano i cambiamenti e la maturazione. In questo testo c’è tutta la veemente saccenteria di un giovane uomo che si affaccia alla vita e, a dispetto della scarsa esperienza, crede di avere capito tutto o quasi, ne “La versione di Barney” sotto un apparente cinismo si nasconde una sconfinata pietà per il genere umano, le sue debolezze e le sue fragilità. Se in uno c’è la feroce determinazione a sottolineare i guasti dei personaggi, a volte fin quasi a farne delle macchiette bidimensionali, nell’altro c’è una malcelata generosità nel perdono, nella comprensione.
Questo è un romanzo che prova a correre e troppo spesso lo fa con palese affanno. Ha un passo irregolare, come in una passeggiata “per vetrine”, in cui dopo dieci metri di cammino ci si ferma per guardare qualcosa che forse non interessa troppo e che, alla successiva esposizione di merce, si è già dimenticato. Si percepisce chiaramente la voglia di vita che tracima dalle pagine, la curiosità di vedere tutti gli spettacoli in scena, di sentire tutte le musiche, di leggere tutti i libri che capitano a tiro e di conoscere quante più persone possibili. Quest’aspetto è così presente che volte il protagonista risulta quasi irritante nella sua necessità di essere al passo con tutto ciò che gli ruota attorno che tra l’altro, in una città come Londra nella fine degli anni sessanta, non è la cosa più facile del mondo. E’ facile avvertire questa sete, anche se potente, come l’unica fonte di energia, ed è altrettanto facile percepirla non come una vera necessità interiore ma come una esigenza per non rimanere estraneo ad un ambiente o alle conversazioni tra conoscenti. Più che una piacevole e appagante nuotata nel mare della cultura appare un disperato annaspare per tenersi a galla.
E’ ovvio che Mordecai Richler è nato con la scrittura in corpo, non era certo il talento a mancargli, ma in questa prova (non a caso uscita in Italia con molti anni di ritardo, forse in Adelphi qualche dubbio lo nutrivano) non si ammirano gli struggenti panorami interiori di altre opere, se ne colgono in filigrana le ombre, e i colori di una luce all’alba, nulla di più.
Se “La storia di Mortimer Griffin” ha un valore, ne ha soprattutto per la firma del suo autore, uno scrittore che negli anni seguenti avrebbe saputo dare prova di sé in modo molto più convincente e consapevole: se non ci fosse stato un “dopo” questo romanzo non sarebbe di certo comparso nelle nostre librerie. Anche se con modalità ovviamente diverse, viene da fare un parallelo con LP come “From Genesis to Revelation” o “Greetings From Asbury Park” o con molti altri esordi, gli esempi potrebbero essere numerosissimi. Se a questi non fosse seguito quel che tutti sanno, da molto tempo non sarebbero più nelle nostre menti o forse non ci sarebbero neppure mai entrati.
Marco Marsullo, I miei genitori non hanno figli Einaudi, 2015. 136 pag. 16,50 euro





 Stavolta Marsullo m’ ha fregato.
Stavolta Marsullo m’ ha fregato.
Ricordando il suo “Atletico Minaccia Football Club” ho comprato questo libricino con la speranza che ne ricalcasse gli aspetti migliori -l’agilità e la relativa brillantezza- e fosse riuscito a colmare quelle lacune di originalità che erano evidenti nel suo romanzo d’esordio.
Purtroppo, pur avendone speranza e predisposizione, non sono riuscito a rintracciare questi aspetti. Il tema centrale è di una disperante banalità: un ragazzo alle soglie dei vent’anni alle prese con la separazione dei genitori e con i primi ostacoli universitari.
Com’è ovvio tutti i temi sono buoni per scrivere bene, il problema nasce quando lo si fa senza aver nulla di nuovo da dire, senza essere in possesso di un punto di vista originale o, per esprimermi come un critico serio, senza averne l’urgenza interiore. Tanto per fare un esempio/paragone che viene subito alla mente, “Il giovane Holden” non parte da presupposti molto diversi, ma i risultati non sono neppure lontanamente paragonabili, se nell’editoria ci fosse una logica non dovrebbero essere neppure pubblicati dalla stessa casa editrice.
Ci vuole un gran coraggio a scrivere ancora di genitori distratti dalle proprie depressioni, manie e regressioni e pensare di poter dire qualcosa di interessante, di non già letto un milione di volte e visto in un miliardo di film. Forse più che coraggio si dovrebbe parlare di temerarietà o di presunzione. Come se non bastasse, le metafore e le iperboli che affollano la scrittura e cercano di darle vitalità sono figlie illegittime delle modalità comiche inaugurate da Paolo Villaggio con i suoi Fantozzi più di quarant’anni fa, una rimasticatura di battute già dette/scritte che non riescono a far sollevare le labbra neppure per un momento.
Penso che prima di scrivere un romanzo o un racconto comico-brillante, per legge o decreto ministeriale, dovrebbe essere prevista la lettura obbligatoria, con tanto di tesina ed esame finale, de “Il motto di spirito” di Sigmund Freud. Di Freud, nel corso dei decenni si e detto più o meno tutto, in negativo e in positivo, ma quel testo è e rimarrà cassazione. Sono certo che dopo quella lettura qualche sedicente scrittore lascerebbe perdere e tutti quelli che avessero intenzioni di perseverare non avrebbero più scuse. Scusate la digressione, proseguo.
Se un piccolo merito va dato a Marsullo, è quello di non aver affrontato il tema con atteggiamento piagnucoloso, con tono lacrimoso, ma aver svolto il suo compitino con un tono lieve e, per quanto mal riusciti, con con tentativi di humour. Purtroppo questo non è stato stato sufficiente a dare un risultato soddisfacente, troppo prevedibili le situazioni ed estremamente blandi e scontati sia i tentativi di vivacizzarle con la scrittura che la caratterizzazione dei personaggi. Volendo andare all’osso, in questo testo non c’è nulla che non sia stato scritto/letto già centinaia di volte, e questo intristisce il lettore. Al contempo, non c’è neppure nulla che infastidisca perché è garbato, beneducato e non disturba.
Esattamente il contrario di ciò che dovrebbe fare un romanzo vero.
Simone Costa, Precipitare Bordeaux, 2015. 114 pag. 14 euro





 Una delle cose che ho la maggiore difficoltà a “digerire”, molto vicino al confine con lo shock anafilattico, sono le cosiddette scene oniriche. Siano esse all’interno di un romanzo o di un film, trovo che nel 99% dei casi siano delle bieche scorciatoie narrative, in altri dei riempitivi e, nelle situazioni peggiori delle giustificazioni/puntelli/punti di sutura/toppe a strutture che non stanno in piedi.
Una delle cose che ho la maggiore difficoltà a “digerire”, molto vicino al confine con lo shock anafilattico, sono le cosiddette scene oniriche. Siano esse all’interno di un romanzo o di un film, trovo che nel 99% dei casi siano delle bieche scorciatoie narrative, in altri dei riempitivi e, nelle situazioni peggiori delle giustificazioni/puntelli/punti di sutura/toppe a strutture che non stanno in piedi.
Su questa affermazione si potrebbe aprire un infinito dibattito, dire che nella storia della letteratura e del cinema mondiale ci sono memorabili e magnifiche scene oniriche e che una presa di posizione così categorica è stupidamente ottusa, ma visto che la rubrica la scrivo io il dibattito finisce qui e vado avanti. Chiarito questo concetto, mi domando: com’è possibile accettare un intero romanzo che, oltretutto alla fine, a tradimento, si svela come una unica scena onirica? E’ una cosa da far venire l’orticaria a un coccodrillo, la nausea ad un avvoltoio, problemi di digestione ad uno squalo bianco! Oltre a questo, a stimolare ulteriormente l’irritazione, c’è anche il realismo di tutta la narrazione del sogno/delirio, appena contrappuntata da qualche stranezza volta a stimolare la curiosità del lettore, indizi che promettono chissà quali svolte e scenari imprevisti per poi perdersi nel nulla perché, appunto, era tutto un sogno.
E poi, facendo anche finta di riuscire a digerire un romanzo onirico, l’autore sarebbe così gentile da spiegarmi perché raccontare un sogno come fosse una banale quotidianità?
La narrativa, per sua intrinseca natura, è una cosa che costa poco, non ha bisogno di effetti speciali o chissà quali investimenti. Mi spiego meglio: per scrivere: “Nella stanza entrarono due zanzare ronzanti ” o “Nella stanza entrarono ventiquattro tirannosauri inferociti” occorre la stessa quantità di inchiostro, la stessa identica spesa. E allora perché limitarsi, perché camuffare un sogno da realtà? Visto che hai deciso di raccontare un sogno fallo senza darti dei limiti, sciogli le briglia dell’immaginazione, chi te lo fa fare di stare a risparmiare? Forse, ed è l’ipotesi che ritengo più probabile, l’autore ci raccontato un sogno soltanto perché gli permetteva di seminare stranezze senza dover poi essere costretto a darne conto e poi, arrivato all’epilogo, aveva anche un comodissimo e banalissimo colpo di scena da scrivere prima della parola fine.
Per dirla in poche parole: una gran presa per il culo. E mi sono serviti anche 14 euro, per avere lo stesso risultato il telegiornale è gratis…
Elmore Leonard, Le storie di Carl Webster Einaudi, 2015. 235 pag. 14 euro
Traduzione: Stefano Massaron





 Penso che Leonard sia un autore fortemente sopravvalutato.
Penso che Leonard sia un autore fortemente sopravvalutato.
Perché tutti si dedicano ad incensarlo? E’ molto simpatico? Paga i critici? Ha molti amici influenti? Non So. Quel che posso dire con certezza è che la stanchezza con cui si trascina questo testo è davvero grande, evidente ed irritante.
Strutturalmente “Le storie di Carl Webster” è uno strambo agglomerato di due racconti brevi, direi introduttivi, e un terzo lungo racconto che poteva tranquillamente (si fa per dire) essere pubblicato come romanzo a sé stante. I primi due racconti sembrano volerci presentare il personaggio. Il primo ci racconta del suo esordio nel magico mondo dell’omicidio, a quattordici anni per fermare un ladro di bestiame. Nel secondo, non molti anni più tardi, ci viene raccontato del primo omicidio da sceriffo federale, volendo esprimermi in burocratese potrei definirlo “nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali”.
Il modo in cui vengono presentati questi due episodi è spaventoso. Pur facendo la tara con il periodo storico, con la pseudocultura americana sulle armi da fuoco e con la insopportabile prosopopea di frontiera, questi due racconti, ed in particolare il primo, non sono accettabili, non nel 2015.
Com’è possibile glorificare un ragazzino di quattordici anni che spara ad un ladro di bestiame?
Com’è possibile apprezzarne così tanto il “gesto tecnico” di averlo ucciso con una fucilata da quattrocento metri di distanza da spingere il titolare delle indagine a dare al ragazzo un biglietto da visita e ad invitarlo ad arruolarsi nel corpo degli sceriffi federali? Anche in questo caso: non so, non ci arrivo. Poi si stupiscono se ogni tre per due qualcuno entra in una scuola e fa una strage. Un minimo di riflessione sull’argomento è troppo difficile?
Ma a parte le considerazioni sociologico-politiche (non è questo il luogo e il momento) quello che affanna nella lettura è l’enorme prevedibilità dell’intero scritto e la stanchezza nell’esporlo, ci si aspetta da un momento all’altro di vedere le macchie di sudore di Leonard sulla pagina.
Il protagonista sembra il nipotino di John Waine o la caricatura del più trito stereotipo del poliziottese americano. Tra le sue frasi preferite troviamo un magnifico esempio di pura idiozia machista: “Se estraggo la pistola lo faccio per uccidere”. Basta questo per capire perfettamente il tono di questo sventurato testo, non occorre aggiungere altro.
Bret Anthony Johnston. Ricordami così Einaudi, 2015. 459 pag. 21 euro.
Traduzione: Federica Aceto





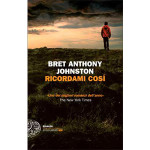 “Ricordami così” è un romanzo potentissimo e contemporaneamente sottile, questa è la sua forza. E’ potente e coinvolgente per l’universalità e l’importanza degli argomenti che affronta ed è sottile per le modalità con cui lo fa, con una discrezione che rasenta la reticenza per ciò che riguarda la “descrizione dei fatti”, preferendo ad essa un costante e incessante scavo psicologico realizzato attraverso il comportamento dei personaggi.
“Ricordami così” è un romanzo potentissimo e contemporaneamente sottile, questa è la sua forza. E’ potente e coinvolgente per l’universalità e l’importanza degli argomenti che affronta ed è sottile per le modalità con cui lo fa, con una discrezione che rasenta la reticenza per ciò che riguarda la “descrizione dei fatti”, preferendo ad essa un costante e incessante scavo psicologico realizzato attraverso il comportamento dei personaggi.
Si può senza dubbio dire che questo sia un romanzo capace di ritracciare il sentiero della narrativa, facendole tornare al suo percorso originale e riportando al centro del testo tutto ciò che solo la letteratura può fare: raccontare ciò che non è possibile vedere diminuendo la “distanza” dai personaggi. Nella narrativa il concetto di “distanza” è piuttosto complesso e non è proprio il caso di fare qui uno “spiegone” infinito, chi sa di cosa sto parlando capirà senza problemi e chi ne ha curiosità si andrà a cercare qualcosa che glielo illustri.
Dopo centinaia, forse migliaia di romanzi che si sono occupati di rapimenti di bambini o adolescenti, che ne hanno descritto le relative indagini e i loro esiti più o meno fausti, finalmente abbiamo un romanzo che si occupa di raccontarci cosa accade o potrebbe accadere in una coppia di genitori che, a quattro anni dalla scomparsa, ritrova un figlio svanito nel nulla quando era dodicenne. A completare il “cast” dei protagonisti del romanzo ci sono il fratello minore del ragazzo ritrovato e, meno importanti ma non secondari, la ragazza di quest’ultimo ed il nonno paterno.
Più o meno le prime cento pagine narrano della vita di questa famiglia nell’imminenza dell’insperato ritorno. Fino a quel punto si può immaginare di essere alle prese con una storia di ricerche o, nel caso di ritrovamento del cadavere del ragazzo, al racconto di una indagine o di una vendetta. Subito dopo, a ricongiunzione avvenuta, si potrebbe pensare alla storia di un faticoso riavvicinamento del ragazzo alla vita normale, una sorta di riabilitazione psichica, oppure ad un esplodere di sentimenti contrastanti e devastanti, ma tutto questo non accade.
Tutto è smorzato, ovattato e, contemporaneamente, iperdescritto.
I genitori, pur avendone ovviamente il desiderio, seguono il consiglio degli psicologi e degli assistenti sociali e non fanno domande sul periodo del rapimento. Questo agevola l’autore ad addentrarsi nei crepacci della psiche e non nella descrizione fatti. Le pochissime notizie o voci o deduzioni sugli accadimenti vengono fuori quasi per caso, da frasi smozzicate o da incontri occasionali di alcuni dei protagonisti. Queste brevi incursioni del mondo esterno sono caratterizzate da un vocabolario estremamente crudo, volgare e privo di pietà, quasi a voler fare da contrappunto alla prudenza e alla delicatezza di ciò che viene detto all’interno della famiglia e all’intero registro del romanzo.
E’ piuttosto evidente che una quantità così grande di dettagli, minuziosamente narrati renda la lettura meno fluida, ma è altrettanto evidente come proprio questo sia stato l’intento di Johnston: scrivere una sorta di antigiallo, partendo da uno spunto tipico di quel genere di romanzo.
Ad eccezione di un paio di scene, quelle in cui nonno e fratello incontrano persone estranee alla famiglia e alla solidarietà della comunità, non si trovano altri passaggi in cui ci siano cambiamenti di ritmo e vocabolario: i cosiddetti colpi di scena sono banditi dal testo come fossero merce di scarto, trucchetti troppo facili, l’intreccio è solo all’interno delle menti dei personaggi.
“Mostrare” i sentimenti e non descriverli è da molti anni uno dei dogmi delle migliori scuole di scrittura degli Stati Uniti e B.A. Johnston, capo della sezione di scrittura creativa dell’università di Harvard, non per caso porta quest’atteggiamento narrativo alle sue estreme conseguenze, al limite dell’omertà, negando l’esposizione del consueto e andando a scavare altrove, in luoghi in cui non esistono più i fatti ma soltanto i loro riflessi e le loro eco interiori.
rubrica a cura di Daniele Borghi