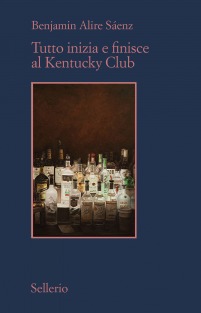Diego De Silva, Terapia di coppia per amanti Einaudi, 2015. 278 pag. 18 euro





 Evidentemente a De Silva sta molto a cuore il tema degli amanti, delle relazioni extraconiugali. Iniziò nel ’99 con “La donna di scorta” e ora lo ripropone, affrontandolo in modo completamente diverso, con questo nuovo romanzo.
Evidentemente a De Silva sta molto a cuore il tema degli amanti, delle relazioni extraconiugali. Iniziò nel ’99 con “La donna di scorta” e ora lo ripropone, affrontandolo in modo completamente diverso, con questo nuovo romanzo.
Il testo di sedici anni fa ricalcava la veste psicologica dei suoi protagonisti. Era esangue, i personaggi avevano personalità sfuggenti, erano marchiati a fuoco dalla loro incapacità di comunicare compiutamente e mettevano a dura prova il lettore con la loro passività esistenziale. In quest’ultimo il panorama narrativo è completamente ribaltato e le personalità dei protagonisti, per quanto a tratti contraddittorie, sono ben strutturate e robuste, quasi ridondanti. I dialoghi tra gli amanti sono scoppiettanti, arguti, spesso divertenti (in certi frangenti in un modo quasi innaturalmente brillanti) e hanno lo stesso ritmo di un combattutissimo assalto di scherma. Le personalità di entrambe sono molto marcate e altrettanto definite, e tutti i personaggi di contorno, anche se il plot concede loro poca ribalta (uno su tutti il padre del protagonista maschile) sono disegnati alla perfezione e sono inseriti nella vicenda in modo impeccabile.
Di certo si potrà eccepire su alcuni dialoghi che risentono troppo dell’elaborazione letteraria: non si può essere sempre brillantissimi ed argutissimi, in particolar modo in un litigio o in un acceso scambio di battute. Questo, in alcuni passaggi, rende lievemente artificioso il testo e il lettore si vede quasi spinto a prendere le distanze.
Anche un voler strafare nella profondità/sapienza del “io so che lei sa che io so che noi sappiamo che loro potrebbero sapere, ma forse non sa che loro sanno che io so mente ma intanto lei non lo sa ecc. ecc…” rende meno piacevole la lettura, e un -quasi- lieto fine che sembra attaccato con il nastro adesivo tolgono un po’ di forza alla narrazione, ma tutto sommato il testo è strutturato ed esposto in maniera più che gradevole. Non passerà alla storia ma intrattiene con piacere, di questi tempi non è poco.
Joshua Ferris, Svegliamoci pure, ma a un’ora decente Beat, 2015. 367 pag. 9 euro
Traduzione: Katia Bagnoli





 A lettura finita, il primo aggettivo che viene in mente, e probabilmente è anche quello giusto, è uno solo Compare come un’enorme insegna al neon lampeggiante su un cielo nero: CERVELLOTICO.
A lettura finita, il primo aggettivo che viene in mente, e probabilmente è anche quello giusto, è uno solo Compare come un’enorme insegna al neon lampeggiante su un cielo nero: CERVELLOTICO.
Il problema delle opere d’arte che non siano concettuali è e rimarrà sempre lo stesso: per potersi dire riuscite dietro ci deve essere un enorme mole di lavoro (dalla prima idea embrionale all’ultimo particolare della realizzazione) su una enorme quantità di aspetti, ovviamente diversi da una forma artistica all’altra, ma l’importante è che questo non sia percepito dalla persona che la va ad affrontare attraverso la propria sensibilità.
Purtroppo in questo caso, perdonatemi la metafora da geometra o da architetto, sembra di vedere le linee a matita sotto quelle a china. Se Ferris sia stato negligente nel non cancellarle o le abbia volutamente lasciate per dare al lettore meno avveduto la possibilità di capire bene tutto e subito non lo sapremo mai, ma l’impressione è netta.
Non credo ci sia bisogno di una storia così artificiosamente complessa per mettere un uomo davanti al suo vuoto esistenziale, un miliardo di romanzi scritti e pubblicati prima di questo lo dimostrano senza tema di smentite, ed è esattamente in questo approccio che Ferris prende una sbandata che non riesce più a correggere. Non c’è bisogno di veder usato il proprio nome in rete per capire che la propria vita sta diventando quella di un pollo d’allevamento, usare uno stratagemma simile testimonia l’incapacità dello scrittore di scavare nelle psicologie dei personaggi.
Oppure, e la cosa sarebbe ancor più riprovevole, si è tentato di far parlare del libro usando la chiave pubblicitaria del rapporto con i social media e la personalità “on-line” che molte persone cercano di costruirsi. Un tema seminuovo in letteratura, attuale e ampiamente dibattuto come questo può senz’altro creare interesse, non mi stupirebbe se qualche genio del marketing libresco avesse colto la palla al balzo e avesse cercato di sfruttarlo al massimo. Circa un miliardo e mezzo di persone hanno un profilo Facebook e centinaia di milioni hanno un account Twitter, il brumeggio dovrebbe portare ad una buona pesca.
Che poi il romanzo sia ben scritto, abbia qualche trovata gustosa e a volte sia anche arguto non è in discussione, è tutto il significato del testo che è difficile da mettere a fuoco. Ma forse sono io che non sono abbastanza intelligente o troppo vecchio e luddista. Non lo escluderei.
Joseph O’Connor, Il gruppo. Guanda, 2015. 372 pag. 18.50 euro
Traduzione: Elisa Banfi





 Con questo godibilissimo romanzo O’Connor ci regala la storia di quello che potrebbe essere un vero gruppo, la vicenda di una band che, tra le consuete mille difficoltà iniziali, sbandamenti, litigi e conflitti di ego, affronta la battaglia con “l’industria dello spettacolo” e ne esce incolume.
Con questo godibilissimo romanzo O’Connor ci regala la storia di quello che potrebbe essere un vero gruppo, la vicenda di una band che, tra le consuete mille difficoltà iniziali, sbandamenti, litigi e conflitti di ego, affronta la battaglia con “l’industria dello spettacolo” e ne esce incolume.
Detta in questo modo potrebbe sembrare una storiella di infimo livello e forse potrebbe anche essere interpretata in questo modo, ma la grande abilità di O’Connor sta nel trasportare il lettore all’interno di questo gruppo estremamente eterogeneo per formazione, personalità e cultura, e fargli vivere da vicino, da dentro, tutte quelle dinamiche che siamo abituati a leggere quando affrontiamo le biografie di gruppi veramente esistiti.
Il colpo d’ala dell’autore -stavo per scrivere colpo di genio ma forse è troppo- risiede nel presupposto che qui, essendo un testo di narrativa, è tutto finto. Non siamo in balia di qualche giornalistucolo che formula ipotesi o sentenzia su fatti e situazioni di cui conosce poco o nulla e dall’esterno. La completa libertà che regala la finzione narrativa consente a O’Connor di immaginare tutto e di rendere tutto credibile, senza forzature, evitando di ricorrere ai “si dice” o, peggio, sommare le poche certezze per costruire fantasmi.
L’io narrante è il chitarrista, ma il testo è arricchito anche da brani di interviste o interventi degli altri componenti della band, cosa che riesce a dare all’intero testo un aspetto corale, una visione d’insieme che una sola voce non sarebbe riuscito a costruire.
Ma l’aspetto che più convince del romanzo è lo sconfinato amore di tutti, in primo luogo dell’autore e a cascata di tutti i membri del gruppo, verso la musica, la sua conoscenza e la costante ricerca dell’aspetto migliore di essa, quella che non ha nulla da condividere con il mercato. Certo, qua e la fanno capolino classifiche di vendita, posti in essa occupati e per quante settimane, ma sembrano più commenti a latere che non aspetti importanti del fare musica.
Volendo adottare un canone di estrema sintesi si potrebbe dire che questo testo è una “falsa biografia”, ma sarebbe estremamente approssimativo e e non si renderebbe giustizia all’autore. La capacità di O’Connor di rendere vivo e alla perfezione il contorno, l’humus culturale, i passaggi esistenziali e i disagi personali sono da romanzo “mainstream”, estremamente ben scritto con una ricerca di semplicità espressiva perfettamente riuscita.
Questo è un romanzo fortemente consigliato a tutti quelli che hanno nel cuore la musica e che hanno iniziato ad amarla qualche decennio fa, quando ancora si ascoltava usando le frittelle di vinile. Tutti gli altri potranno anche avvicinarglisi con soddisfazione, ma temo non potranno mai afferrare quel profumo, quell’aura di misteriosa imperfezione e il fascino quasi antico di quei tempi che non gli appartengono. Per storia personale e per pressioni commerciali.
Mi dispiace per loro, davvero.
Emanuele Trevi, Il popolo di legno. Einaudi, 2015. 192 pag. 18 euro.





 Per non dar luogo ad equivoci sarò chiaro sin dall’inizio, mi inginocchio, cospargo il capo di cenere e confesso: questo romanzo non l’ho capito. Non ho capito (se c’è) la simbologia del protagonista, un prete spretato che non crede più non solo in Dio, ma praticamente in qualsiasi altra cosa abbia a che fare con l’umano, sciocchezze come l”informazione, la cultura, il pensiero ecc. ecc. Non ho capito perché questo nichilista esponenziale si adoperi per avere un programma radio in cui cerca di illustrare ai calabresi (soprannominati “il popolo di legno” da cui il titolo) quanto i messaggi di “Pinocchio” siano da interpretare esattamente al contrario di quanto fatto finora e, soprattutto, visto che non gli frega niente di nulla ad eccezione della sua carnosa sposa, perché contravvenga al suo credo mettendosi a fare di nuovo il predicatore, stavolta laico ed etero diffuso.
Per non dar luogo ad equivoci sarò chiaro sin dall’inizio, mi inginocchio, cospargo il capo di cenere e confesso: questo romanzo non l’ho capito. Non ho capito (se c’è) la simbologia del protagonista, un prete spretato che non crede più non solo in Dio, ma praticamente in qualsiasi altra cosa abbia a che fare con l’umano, sciocchezze come l”informazione, la cultura, il pensiero ecc. ecc. Non ho capito perché questo nichilista esponenziale si adoperi per avere un programma radio in cui cerca di illustrare ai calabresi (soprannominati “il popolo di legno” da cui il titolo) quanto i messaggi di “Pinocchio” siano da interpretare esattamente al contrario di quanto fatto finora e, soprattutto, visto che non gli frega niente di nulla ad eccezione della sua carnosa sposa, perché contravvenga al suo credo mettendosi a fare di nuovo il predicatore, stavolta laico ed etero diffuso.
Non sono riuscito a capire il motivo per cui gli stessi proprietari della radio da cui trasmette il suo programma, una famiglia organica alla malavita organizzata, decida di farlo fuori insieme al suo amico d’infanzia, direttore artistico della stessa radio, omosessuale, alcolizzato e cocainomane. Se anche qui c’erano delle allegorie temo di averle mancate. Forse il senso della presenza della ‘ndrangheta nel romanzo risiede nel fatto che ormai, in narrativa, nelle fiction tv e nella cinematografia, la criminalità organizzata è come il grigio o il nero nell’abbigliamento: sta bene con tutto. Non so come altro giustificarla.
Oltre a questo c’è anche una complicazione in più: spesso non riesce a capire se le parole esterne ai dialoghi siano la “voce” del protagonista o quella dell’autore. Se quest’atteggiamento narrativo è frutto di una disattenzione formale sarebbe già riprovevole, se fosse una scelta sarebbe ancora peggio perché aggiungerebbe confusione alla confusione.
Immagino che la mia incapacità di capire sia da attribuire soltanto alla mia stupidità, Einaudi non pubblicherebbe mai un testo non di altissimo livello…
Ilaria Gaspari, Etica dell’acquario. Voland, 2015. 191 pag. 15 euro.





Questo romanzo stupisce moltissimo.
 Lo stupore più grande me lo sono procurato da solo riuscendo a leggere fino all’ultima pagina, ma anche molti altri aspetti di questa “operazione editoriale” sono ammantati da un’aura di inspiegabilità. Innanzitutto dovrebbero spiegarmi cos’ha questo testo per poter essere pubblicato da Voland, una casa editrice che di certo non è Mondazzoli o Adelphi ma che ha comunque una sua dignità consolidata nel corso dei decenni. Questo è davvero inspiegabile, soprattutto perché, nell’intero testo si percepisce nitidamente la mancanza di un lavoro di editing, sia dal punto di vista della cura linguistica che da quello strutturale.
Lo stupore più grande me lo sono procurato da solo riuscendo a leggere fino all’ultima pagina, ma anche molti altri aspetti di questa “operazione editoriale” sono ammantati da un’aura di inspiegabilità. Innanzitutto dovrebbero spiegarmi cos’ha questo testo per poter essere pubblicato da Voland, una casa editrice che di certo non è Mondazzoli o Adelphi ma che ha comunque una sua dignità consolidata nel corso dei decenni. Questo è davvero inspiegabile, soprattutto perché, nell’intero testo si percepisce nitidamente la mancanza di un lavoro di editing, sia dal punto di vista della cura linguistica che da quello strutturale.
Certo, dal punto di vista linguistico non sono errori marchiani, tutt’altro, ma infastidiscono e portano a pensare di trovarsi a leggere un testo poco curato, prematuramente stampato. Potrei riportare alcuni esempi ma, non avendoli sottolineati durante la lettura, dovrei rileggere tutto daccapo e francamente non ne ho assolutamente voglia. Anche le infinite ripetizioni dei concetti, delle situazioni, dei flashback, rimasticati e sputati su carta con approssimazione e superficialità nuocciono alla qualità del tempo libero del lettore. Oltre a questi continui noiosi salti all’indietro, più della metà del romanzo è formato da questi ultimi, c’è o ci dovrebbe essere anche una vicenda al presente. Purtroppo è talmente fumosa e campata in aria che all’inizio di ogni capitolo non si sa se augurarsi un progresso nella “storia” (che dal punto di vista legale-poliziesco è a dir poco campata in aria) o se farsi tornire gli zebedei con la vita quotidiana (di quindici anni prima) all’interno degli alloggi per studenti.
Per sintetizzare si potrebbe dire che questo romanzo poteva essere tranquillamente racchiuso nelle dieci cartelle che chiedono ai loro autori i cosiddetti settimanali femminili (Grand Hotel, Love Story, Confidenze, Intimità ecc. ecc), quei racconti che pagano 15 euro a cartella e poi spacciano per racconti di vita vissuta.
In quel caso sarebbe stato quasi leggibile, se non altro sarebbero occorsi soltanto una ventina di minuti…
rubrica a cura di Daniele Borghi