Agota Kristof Trilogia della città di K– Einaudi, 1998, 2000, 2006, 2014. 379 pag. 13 euro





 Il romanzo di Kristof è senza dubbio un testo interessante dal punto di vista della scrittura. Giorgio Manganelli, nella quarta di copertina, lo descrive così: “Una prosa di perfetta, innaturale secchezza, una prosa che ha l’andatura di una marionetta assassina”. Almeno per ciò che riguarda il primo dei tre romanzi brevi, sia una descrizione perfetta, non riesco ad immaginare nulla di più adeguato. In ogni opera di narrativa non è tanto importante il “cosa” viene narrato ma il “come” e questo testo ne è la prova più evidente. Nel primo dei tre romanzi, “Il grande quaderno”, che è la narrazione della durissima infanzia di due gemelli, la struttura è sorprendente e la scrittura efficacissima. In un passo, quasi nascosto tra le pieghe di un altro tema, è possibile leggere una sorta di manifesto programmatico della scrittura, una scrittura che si potrebbe definire etica. Il brano è questo. Scriveremo: “Noi mangiamo molte noci” e non “Amiamo le noci”, perché il verbo amare non è un verbo sicuro, manca di precisione e di obiettività. “Amare le noci” e “amare nostra madre” non può voler dire la stessa cosa. La prima formula designa un gusto gradevole in bocca, la seconda un sentimento”.
Il romanzo di Kristof è senza dubbio un testo interessante dal punto di vista della scrittura. Giorgio Manganelli, nella quarta di copertina, lo descrive così: “Una prosa di perfetta, innaturale secchezza, una prosa che ha l’andatura di una marionetta assassina”. Almeno per ciò che riguarda il primo dei tre romanzi brevi, sia una descrizione perfetta, non riesco ad immaginare nulla di più adeguato. In ogni opera di narrativa non è tanto importante il “cosa” viene narrato ma il “come” e questo testo ne è la prova più evidente. Nel primo dei tre romanzi, “Il grande quaderno”, che è la narrazione della durissima infanzia di due gemelli, la struttura è sorprendente e la scrittura efficacissima. In un passo, quasi nascosto tra le pieghe di un altro tema, è possibile leggere una sorta di manifesto programmatico della scrittura, una scrittura che si potrebbe definire etica. Il brano è questo. Scriveremo: “Noi mangiamo molte noci” e non “Amiamo le noci”, perché il verbo amare non è un verbo sicuro, manca di precisione e di obiettività. “Amare le noci” e “amare nostra madre” non può voler dire la stessa cosa. La prima formula designa un gusto gradevole in bocca, la seconda un sentimento”.
Può sembrare una banalità, ma molti sedicenti scrittori dovrebbero abbeverarsi e lasciarsi guidare da queste parole, ricominciando ad usare le parole con l’etica del vocabolario.
Se “Il grande quaderno” ha un impatto profondo, le due restanti parti sembrano risentire di una certa stanchezza, come se l’asciuttezza del testo non fosse più “il” modo di narrare dell’autore ma “un” modo scelto dall’autore per narrare, la stessa differenza che può esserci tra una foto in posa ed una scattata senza avvertire.
Dato che si tratta sempre di impressioni e non di una realtà oggettiva, potrebbe anche darsi che, dopo aver letto “Il grande quaderno”, io mi sia in qualche modo assuefatto al modo narrativo di Kristof e non sia più riuscito a coglierne e apprezzarne l’originalità e la crudezza Questa non è un’ipotesi da scartare, ma non la so esaminare fino in fondo e purtroppo, visto che ormai ho già letto l’intera trilogia, non avrò mai più la possibilità di ripetere l’esperienza.
Enrico Pandiani. Nel regno di Acilia – Rizzoli, 2004. 400 pag. 11 euro





 Ormai è certo, esiste uno strambo virus che, ad un certo punto della vita di uno scrittore, colpisce senza pietà. Non è dato sapere da dove venga e quali siano i veicoli di contagio, ma escludendo gli autori di genere, i seriali e i seriosi, è quasi inevitabile che colpisca. Il virus in questione è la “storia di adolescenti”. Non perdona, rarissimi sono i casi di scrittori che non l’hanno contratto. E lo dico a ragion veduta: per certi versi ne sono rimasto vittima anch’io. Il guaio è che spesso sono storie autobiografiche e che, altrettanto spesso, l’autore sovrastima l’interesse che le sue vicende adolescenziali possano suscitare. Questo per dire che occorre una gran pazienza e buona volontà per leggerne un’altra. E profonda inclinazione all’indulgenza e alla comprensione umana per non mandare a cagare l’autore. Non si può assolutamente affermare che il romanzo di Pandiani abbia difetti di struttura o scrittura o di qualsiasi altro elemento si voglia prendere in esame per dare un giudizio, il problema è che di ragazzini non se ne può più. Anzi, per essere più precisi, non ne posso più io. So che questa è una “non recensione”, ma soltanto uno sfogo: non posso farci niente, non riesco ad essere né oggettivo ne distaccato.
Ormai è certo, esiste uno strambo virus che, ad un certo punto della vita di uno scrittore, colpisce senza pietà. Non è dato sapere da dove venga e quali siano i veicoli di contagio, ma escludendo gli autori di genere, i seriali e i seriosi, è quasi inevitabile che colpisca. Il virus in questione è la “storia di adolescenti”. Non perdona, rarissimi sono i casi di scrittori che non l’hanno contratto. E lo dico a ragion veduta: per certi versi ne sono rimasto vittima anch’io. Il guaio è che spesso sono storie autobiografiche e che, altrettanto spesso, l’autore sovrastima l’interesse che le sue vicende adolescenziali possano suscitare. Questo per dire che occorre una gran pazienza e buona volontà per leggerne un’altra. E profonda inclinazione all’indulgenza e alla comprensione umana per non mandare a cagare l’autore. Non si può assolutamente affermare che il romanzo di Pandiani abbia difetti di struttura o scrittura o di qualsiasi altro elemento si voglia prendere in esame per dare un giudizio, il problema è che di ragazzini non se ne può più. Anzi, per essere più precisi, non ne posso più io. So che questa è una “non recensione”, ma soltanto uno sfogo: non posso farci niente, non riesco ad essere né oggettivo ne distaccato.
Posso facilmente immaginare che molti potranno obiettare e citare memorabili esempi di romanzi imperniati su questo tema, testi che hanno valore assoluto. Non voglio negare questo, anch’io sono affezionato a molte di queste storie (il pensiero mi corre subito a “Stand by me” di S. King, ad esempio), la mia perplessità nasce dalla scarsa autocritica di molti scrittori che si ostinano ad affrontare questo tema. La “storia di adolescenti” sta diventando sempre più simile alla “storia d’amore” e cioè un terreno fittamente minato dal troppo scritto, in cui essere originali e avere qualcosa da dire che non sia stato succhiato fino al midollo da altri autori è un’impresa più che disperata, in cui le possibilità di successo sono veramente pochissime.
Negli ultimi anni ricordo soltanto un romanzo che riusciva ad investire di una nuova luce e affascinante energia la vicenda di una adolescente che era anche l’io narrante, sto parlando di “Amabili resti” di Alice Sebold. Per ottenere quel magnifico risultato l’autrice ha però fatto ricorso ad una storia che ben poco aveva a vedere con il reale, con il tangibile, forse proprio per le ragioni di cui scrivevo prima. Per tornare al romanzo di Pandiani, come diceva un noto conduttore televisivo di qualche anno fa, una domanda sorge spontanea: dopo quanto scritto da Pasolini cinquant’anni fa e tutto quello che è seguito dopo, qualcuno sentiva la necessità di un’altra storia di adolescenti ambientata nell’estrema periferia romana negli anni che hanno seguito la fine della guerra? Io no.
Lisa Moore. Senza un ragionevole dubbio – Bollati Boringhieri. 310 pag. 17.50 euro.





 Quello di Lisa Moore è senz’altro un nuovo modo di raccontare una storia di crimine. Forse perchè, come appare evidente nella realtà e in ogni pagina del romanzo, trasportare un grosso carico di marijuana dalla Colombia al Canada non è questo gran crimine contro l’umanità. “E’ solo roba da fumare” sintetizza brillantemente il protagonista… ed è difficile dargli torto. Se si danno vent’anni ad uno che trasporta un carico di marijuana quale dovrebbe essere la pena per le multinazionali del tabacco? Comunque, al di là delle dissertazioni proibizioniste/antiproibizioniste, che non sono il tema di questa rubrica, va detto che la Moore fotografa la crime story con un obbiettivo che solo lei ha trovato in commercio. Un’ottica che a volte sembra un grandangolo e a volte zooma con la brutalità di un telescopio, con virtuosismi di gran classe. Da molti anni film e romanzi che trattano questi argomenti tendono ad assomigliarsi sempre di più. Lei, che il dio dei romanzi gliene renda merito, ha deciso di cambiare strada. Nessun “montaggio” serrato, assenza completa di climax e colpi di scena inesistenti. Tanto per chiarire l’approccio, già dal titolo originale: “Caught” (per chi non conosce l’inglese: prigioniero, impigliato, preso) quasi come dichiarazione di intenti, la Moore non punta sull’ansia del lettore, ma il suo romanzo è animato da una sottile eppure decisa tensione narrativa che, pur concentrandosi su “scene” a volte secondarie alla trama, non lascia scampo al lettore e lo cattura con la sua levigatezza mai banale, con la pura forza dell’affabulazione e l’originalità delle scelte narrative. Non è un capolavoro ma affascina, non è Times Square ma un bellissimo bivio alberato dall’interessantissima prospettiva. Non è Connelly e non è Homes, ma ha un ritmo proprio e una propria vista, aguzza e profonda sulle fragilità umane. In questi tristissimi tempi di letteratura sterilizzata, confezionata, surgelata e venduta come i bastoncini di pesce il merito non è da poco.
Quello di Lisa Moore è senz’altro un nuovo modo di raccontare una storia di crimine. Forse perchè, come appare evidente nella realtà e in ogni pagina del romanzo, trasportare un grosso carico di marijuana dalla Colombia al Canada non è questo gran crimine contro l’umanità. “E’ solo roba da fumare” sintetizza brillantemente il protagonista… ed è difficile dargli torto. Se si danno vent’anni ad uno che trasporta un carico di marijuana quale dovrebbe essere la pena per le multinazionali del tabacco? Comunque, al di là delle dissertazioni proibizioniste/antiproibizioniste, che non sono il tema di questa rubrica, va detto che la Moore fotografa la crime story con un obbiettivo che solo lei ha trovato in commercio. Un’ottica che a volte sembra un grandangolo e a volte zooma con la brutalità di un telescopio, con virtuosismi di gran classe. Da molti anni film e romanzi che trattano questi argomenti tendono ad assomigliarsi sempre di più. Lei, che il dio dei romanzi gliene renda merito, ha deciso di cambiare strada. Nessun “montaggio” serrato, assenza completa di climax e colpi di scena inesistenti. Tanto per chiarire l’approccio, già dal titolo originale: “Caught” (per chi non conosce l’inglese: prigioniero, impigliato, preso) quasi come dichiarazione di intenti, la Moore non punta sull’ansia del lettore, ma il suo romanzo è animato da una sottile eppure decisa tensione narrativa che, pur concentrandosi su “scene” a volte secondarie alla trama, non lascia scampo al lettore e lo cattura con la sua levigatezza mai banale, con la pura forza dell’affabulazione e l’originalità delle scelte narrative. Non è un capolavoro ma affascina, non è Times Square ma un bellissimo bivio alberato dall’interessantissima prospettiva. Non è Connelly e non è Homes, ma ha un ritmo proprio e una propria vista, aguzza e profonda sulle fragilità umane. In questi tristissimi tempi di letteratura sterilizzata, confezionata, surgelata e venduta come i bastoncini di pesce il merito non è da poco.
Ben Brooks. Lolito – ISBN Edizioni. 288 pag. 17.50 euro.





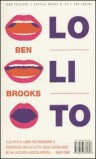 Nella storia della letteratura mondiale sono rarissimi i casi in cui un autore abbia manifestato compiutamente e profondamente il proprio talento in giovanissima età. Ben Brooks non fa parte di questa schiera di eletti. Certo, per essere un ventiduenne, per avere già alle spalle cinque romanzi e un serie di riconoscimenti è già una sorta di predestinato, ma a leggere quest’ultimo testo non si ha l’impressione di essere di fronte a un autore che possa rivoluzionare o almeno scuotere lo stagnante mondo della narrativa internazionale. La sua prosa è frizzante e fresca, come un bicchiere di acqua minerale molto gasata ma, proprio come nel caso dell’acqua, in bocca non rimane nessun sapore e la pancia rischia di gonfiarsi troppo. Probabilmente Brooks non ha nessuna responsabilità al riguardo, ma anche il titolo e la quarta di copertina sono una piccola truffa. Entrambe lasciano chiaramente intendere che il fulcro della narrazione sia la relazione tra una signora – non si capisce bene se trentacinquenne o quarantaseienne, nelle note c’è un’età diversa da quella che lei dichiara- e un quindicenne e, paracitando (ma sarebbe meglio dire paraculando) Nabokov, traggono in inganno il compratore. In realtà la storia di cui sopra è solo una piccola parte del romanzo, tra l’altro la meno credibile e la più “tirata via”, senza alcun approfondimento, senza un vero nesso con tutto il resto della vicenda e confezionata (sì, confezionata) con un susseguirsi di scene che hanno l’unico intento di apparire singolari, strane, sopra le righe. “Sfiziose”, direbbe qualcuno che mi starebbe immediatamente sui coglioni. Il reale fulcro è la vita sregolata e alcolica di un quindicenne che scopre un’infedeltà della “fidanzatina” e, com’è d’obbligo, ne soffre molto. Si potrà dire che nell’affrontare questo tema Brooks ha avuto coraggio, ma io la definirei temerarietà, incoscienza o anche qualcosa di peggio. Come può un ragazzino, talentuoso quanto si vuole, prendere in mano una tematica così prosciugata da ogni possibile variazione sul tema e pensare di cavarne fuori qualcosa di originale? Questa è presunzione, altro che coraggio. C’è una bella differenza.
Nella storia della letteratura mondiale sono rarissimi i casi in cui un autore abbia manifestato compiutamente e profondamente il proprio talento in giovanissima età. Ben Brooks non fa parte di questa schiera di eletti. Certo, per essere un ventiduenne, per avere già alle spalle cinque romanzi e un serie di riconoscimenti è già una sorta di predestinato, ma a leggere quest’ultimo testo non si ha l’impressione di essere di fronte a un autore che possa rivoluzionare o almeno scuotere lo stagnante mondo della narrativa internazionale. La sua prosa è frizzante e fresca, come un bicchiere di acqua minerale molto gasata ma, proprio come nel caso dell’acqua, in bocca non rimane nessun sapore e la pancia rischia di gonfiarsi troppo. Probabilmente Brooks non ha nessuna responsabilità al riguardo, ma anche il titolo e la quarta di copertina sono una piccola truffa. Entrambe lasciano chiaramente intendere che il fulcro della narrazione sia la relazione tra una signora – non si capisce bene se trentacinquenne o quarantaseienne, nelle note c’è un’età diversa da quella che lei dichiara- e un quindicenne e, paracitando (ma sarebbe meglio dire paraculando) Nabokov, traggono in inganno il compratore. In realtà la storia di cui sopra è solo una piccola parte del romanzo, tra l’altro la meno credibile e la più “tirata via”, senza alcun approfondimento, senza un vero nesso con tutto il resto della vicenda e confezionata (sì, confezionata) con un susseguirsi di scene che hanno l’unico intento di apparire singolari, strane, sopra le righe. “Sfiziose”, direbbe qualcuno che mi starebbe immediatamente sui coglioni. Il reale fulcro è la vita sregolata e alcolica di un quindicenne che scopre un’infedeltà della “fidanzatina” e, com’è d’obbligo, ne soffre molto. Si potrà dire che nell’affrontare questo tema Brooks ha avuto coraggio, ma io la definirei temerarietà, incoscienza o anche qualcosa di peggio. Come può un ragazzino, talentuoso quanto si vuole, prendere in mano una tematica così prosciugata da ogni possibile variazione sul tema e pensare di cavarne fuori qualcosa di originale? Questa è presunzione, altro che coraggio. C’è una bella differenza.
David Wagner. Il corpo della vita – Fazi Editore, 2014. 281 pag. 16.50 euro





 Prima di ogni altra considerazione occorre fare chiarezza: questo non è un romanzo in senso stretto. Nel tentativo di dare un definizione che, per quanto approssimativa, possa somigliare a una realtà oggettiva, lo si potrebbe definire il diario psicologico di una malattia. Il protagonista è affetto da una rara patologia che, ad un certo punto della sua esistenza, (non è dato saperlo con esattezza, ma a spanne si potrebbe pensare intorno ai quarant’anni) lo costringe a subire un trapianto di fegato. Da qui, anzi, da poco prima, inizia il racconto. Un racconto che si dipana per flash: in 281 pagine si contano 277 microcapitoli. Considerando le pagine bianche e quelle che recano soltanto i titoli delle varie parti di cui è composto il testo è facile capire come siano veri e propri lampi di narrativa, a volte composti di una sola frase. Nella maggioranza dei casi questi microcapitoli narrano di impressioni, situazioni e fatti relativi alla malattia, all’intervento chirurgico e ai pensieri per la donatrice (lui la immagina donna), ma non raramente si incontrano brani incentrati su viaggi, sulla figlia, su amanti perdute, sulla madre scomparsa da tempo, su situazioni strambe vissute in passato, ad su osservazioni della natura che cambia al di là dal vetro della sua stanza e su molti altri argomenti. Come ho scritto all’inizio, un testo come questo non può essere definito un romanzo eppure, con il sommarsi di questi brevi scritti, si ha la netta impressione che la narrazione voglia e riesca a costruire e definire il personaggio del protagonista molto meglio di quanto riescano a fare autori che cercano di raggiungere lo stesso obiettivo attraverso una struttura più convenzionale e collaudata. In estrema sintesi questo è un testo da consigliare a chi, leggendo, non ha la smania di “vedere come va a finire” ma a chi, nella lettura, cerca suggestioni, spunti di riflessione. A chi, durante la lettura, ama poggiare il libro sul bracciolo del divano e ascoltare in se stesso gli echi di ciò che ha appena colto con gli occhi.
Prima di ogni altra considerazione occorre fare chiarezza: questo non è un romanzo in senso stretto. Nel tentativo di dare un definizione che, per quanto approssimativa, possa somigliare a una realtà oggettiva, lo si potrebbe definire il diario psicologico di una malattia. Il protagonista è affetto da una rara patologia che, ad un certo punto della sua esistenza, (non è dato saperlo con esattezza, ma a spanne si potrebbe pensare intorno ai quarant’anni) lo costringe a subire un trapianto di fegato. Da qui, anzi, da poco prima, inizia il racconto. Un racconto che si dipana per flash: in 281 pagine si contano 277 microcapitoli. Considerando le pagine bianche e quelle che recano soltanto i titoli delle varie parti di cui è composto il testo è facile capire come siano veri e propri lampi di narrativa, a volte composti di una sola frase. Nella maggioranza dei casi questi microcapitoli narrano di impressioni, situazioni e fatti relativi alla malattia, all’intervento chirurgico e ai pensieri per la donatrice (lui la immagina donna), ma non raramente si incontrano brani incentrati su viaggi, sulla figlia, su amanti perdute, sulla madre scomparsa da tempo, su situazioni strambe vissute in passato, ad su osservazioni della natura che cambia al di là dal vetro della sua stanza e su molti altri argomenti. Come ho scritto all’inizio, un testo come questo non può essere definito un romanzo eppure, con il sommarsi di questi brevi scritti, si ha la netta impressione che la narrazione voglia e riesca a costruire e definire il personaggio del protagonista molto meglio di quanto riescano a fare autori che cercano di raggiungere lo stesso obiettivo attraverso una struttura più convenzionale e collaudata. In estrema sintesi questo è un testo da consigliare a chi, leggendo, non ha la smania di “vedere come va a finire” ma a chi, nella lettura, cerca suggestioni, spunti di riflessione. A chi, durante la lettura, ama poggiare il libro sul bracciolo del divano e ascoltare in se stesso gli echi di ciò che ha appena colto con gli occhi.
rubrica a cura di Daniele Borghi




