Sandrone Dazieri. Uccidi il padre. Mondadori, 2015. 564 pag.18 euro.





 Un romanzo di chiarissima impronta nordamericana. Un plot dall’intreccio complesso ma coerente e non difficile da seguire, una scrittura asciutta e un ritmo molto serrato: gli amanti del thriller non credo possano chiedere di meglio. Questo romanzo non ha nulla da invidiare a testi di celebratissimi e vendutissimi autori americani e sono certo che se l’azione non si svolgesse in Italia, i nomi dei personaggi fossero inglesi e l’autore avesse usato un nome de plume dalla sonorità anglofona, il romanzo di cui sto scrivendo sarebbe un successo mondiale.
Un romanzo di chiarissima impronta nordamericana. Un plot dall’intreccio complesso ma coerente e non difficile da seguire, una scrittura asciutta e un ritmo molto serrato: gli amanti del thriller non credo possano chiedere di meglio. Questo romanzo non ha nulla da invidiare a testi di celebratissimi e vendutissimi autori americani e sono certo che se l’azione non si svolgesse in Italia, i nomi dei personaggi fossero inglesi e l’autore avesse usato un nome de plume dalla sonorità anglofona, il romanzo di cui sto scrivendo sarebbe un successo mondiale.
Dazieri ci ha per anni piacevolmente intrattenuto con le avventure del suo psicotico investigatore sui generis, “il Gorilla”, da cui è stato tratto anche un brutto film con Claudio Bisio, ma ora ha cambiato drasticamente rotta. Non più ambienti leoncavallini, non più sottobosco milanese ma una vicenda che, anche se interamente ambientata in Italia, ha il sapore e il passo del thriller internazionale.
I due personaggi principali sono una poliziotta traumatizzata da una disastrosa operazione internazionale di polizia ed una sorta di reduce da un rapimento durato più di dieci anni. Com’è facilmente intuibile tutto il loro rapporto e l’indagine che condurranno insieme, sarà pesantemente condizionata dalle loro ferite interiori e dalle loro durissime esperienze personali.
Anche lo stesso dipanarsi delle indagini stesse è figlio della letteratura noir nordamericana. L’accanimento, la competenza e la tenacia con cui i due percorrono le strade d’Italia alla ricerca del “Padre” è molto più simile a quella dei detective di Connelly o Deaver che non all’approccio artigianale a cui ci hanno abituato i gialli nostrani. Non so se sia tutto questo sia un bene o un male, se l’adeguarsi ad un sorta di format internazionale sia una mossa commerciale oppure un modo per scrollarsi di dosso la tradizione quasi folkloristica del giallo italiano, e neppure se sia il frutto di un ragionamento o soltanto di una sorta di “salto di qualità” nella conoscenza della materia trattata, sta di fatto che Dazieri ha portato a termine il suo lavoro con estrema dignità e compiutezza. Ad un thriller non credo si possa chiedere di più.
Carl Aderhold. La strage degli imbecilli.Fazi Editore, 2015. 336 pagine. 16 euro
Traduzione: Federica Angelini





 Nelle 336 pagine di questo romanzo sono descritti 140 omicidi, per fortuna del lettore almeno un paio sono di massa. Tutte le altre inutili parole di questo libro inutile e fastidioso come le zanzare nelle notti estive, sono sprecate nel tentativo di illustrare i motivi per cui questi omicidi vengono portati a compimento.
Nelle 336 pagine di questo romanzo sono descritti 140 omicidi, per fortuna del lettore almeno un paio sono di massa. Tutte le altre inutili parole di questo libro inutile e fastidioso come le zanzare nelle notti estive, sono sprecate nel tentativo di illustrare i motivi per cui questi omicidi vengono portati a compimento.
Le ragioni per cui questo insopportabile personaggio uccide un così grande numero di persone sono i più vari, elencarli tutti sarebbe noioso e inutile, ma se ve ne viene in mente uno stupido state pur certi che sarà nella lista. Naturalmente sono accuratamente evitati gli omicidi che potrebbero avere una qualsiasi forma di ragione convenzionale (raptus, interesse, gelosia, odio ecc. ecc.) perché il solo motivo per cui quest’uomo uccide risiede nella presunta imbecillità delle sue vittime.
Il paradosso è che per tutto il tempo in cui non è impegnato a descrivere gli omicidi, l’autore fa interrogare il protagonista sulla natura dell’imbecillità, cercando di farlo arrivare ad una definizione incontrovertibile, definitiva. Naturalmente il solo vero imbecille non riesce a farlo.
Va sottolineato il fatto che, a parte poche eccezioni, le 140 vittime di questo serial killer sui generis, fanno parte della sua cerchia di conoscenti, amici e parenti, e tutto questo senza che la polizia riesca a trovare un collegamento che apparirebbe evidente anche ad un merluzzo.
Non è un giallo, non è divertente, non è satirico, non è scritto con una “voce” originale, non è niente. A questo punto la chiusura di questa recensione appare più che scontata: e se l’imbecillità fosse scrivere un romanzo del genere e pubblicarlo? E subito di seguito mi viene un dubbio maligno e insistente: se tutta questa operazione avesse visto la luce soltanto perché l’autore è un potentissimo personaggio dell’editoria francese (storico di fama e direttore editoriale della Larousse) e nel non leccargli il didietro scrivendo recensioni negative si rischiasse di essere marchiati a fuoco e messi sul grande libro nero?
Jack Ritchie. Un metro quadrato di Texas. Marcos y Marcos, 2001 (1961). 160 pag. 10 euro
Traduzione F. Giannetto





 In questa raccolta di brevi racconti, probabilmente non la migliore di Ritchie, si ritrovano tutti gli elementi fondanti della sua narrativa. Ogni racconto ha una sua fortissima identità, ogni racconto ha un suo rapidissimo sviluppo e ogni racconto ha un finale che, se non a sorpresa, è sicuramente “a schiaffo”. Molti di essi sono sostanzialmente dei micronoir e non pochi si articolano su pochissime scene. Queste peculiarità, abituati come siamo a thriller di 500 pagine in cui ogni anfratto della vicenda è esplorato fino allo sfinimento, può lasciare interdetti e creare una sorta di spaesamento, ma questo accade soprattutto dopo la lettura dei primissimi racconti, prima che il lettore riesca a capire il passo narrativo che contraddistingue questa raccolta. Una volta capito e assimilato il “modo” dell’autore è molto facile riuscire a godere della sua scrittura e ad apprezzarne l’originalità.
In questa raccolta di brevi racconti, probabilmente non la migliore di Ritchie, si ritrovano tutti gli elementi fondanti della sua narrativa. Ogni racconto ha una sua fortissima identità, ogni racconto ha un suo rapidissimo sviluppo e ogni racconto ha un finale che, se non a sorpresa, è sicuramente “a schiaffo”. Molti di essi sono sostanzialmente dei micronoir e non pochi si articolano su pochissime scene. Queste peculiarità, abituati come siamo a thriller di 500 pagine in cui ogni anfratto della vicenda è esplorato fino allo sfinimento, può lasciare interdetti e creare una sorta di spaesamento, ma questo accade soprattutto dopo la lettura dei primissimi racconti, prima che il lettore riesca a capire il passo narrativo che contraddistingue questa raccolta. Una volta capito e assimilato il “modo” dell’autore è molto facile riuscire a godere della sua scrittura e ad apprezzarne l’originalità.
E’ paradossale che per cogliere elementi di originalità di un testo si debba ricorrere ad una raccolta di racconti pubblicata più di cinquant’anni fa, ma la progressiva omologazione dei prodotti editoriali (ormai i romanzi si chiamano così e questo, purtroppo, la dice lunghissima) costringe chi vuole leggere a tornare indietro a scovare autori “minori”, non certo per talento ma solo per fatturato.
Ritchie non è mai ruffiano, non strizza mai l’occhio al lettore, non condisce mai nulla con la salsa rosa dei sentimenti, va dritto per la sua strada e se ne sbatte di tutto il resto.
Anche per questo motivo i suoi racconti possono in qualche modo apparire alieni, distantissimi dai canoni a cui siamo profondamente assuefatti. E’ probabile che a molti lettori questi testi possano sembrare elementari, forse addirittura rozzi, a me hanno fatto venire in mente il ripulisti fatto dall’onda punk, una marea che ha fatto terra bruciata di certo rock decadente, melenso e sostanzialmente insignificante e inutile. E questo non può che portarmi a consigliarne la lettura.
John Connolly. Un’anima che brucia Fanucci Editore, 2015 (2011). 478 pag. euro
Traduzione: Federico Lopiparo





 Connolly è uno dei pochi giallisti in circolazione che riesce a trasformare un romanzo di genere in un romanzo mainstream, e questo sarebbe già sufficiente a porlo su un piedistallo. Forse questa sua capacità di scavare nell’animo dei personaggi non è funzionale al ritmo a cui siamo abituati in un testo thrilling, noir, giallo o come lo si voglia battezzare, sta di fatto che i personaggi di Connolly non si dimenticano appena dopo aver letto l’ultima pagina come di solito accade per quelli di questo genere di romanzi. Quanto appena scritto, naturalmente, può essere percepito come un pregio o un difetto a seconda della sensibilità letteraria di ognuno, ma di certo è una peculiarità molto rara.
Connolly è uno dei pochi giallisti in circolazione che riesce a trasformare un romanzo di genere in un romanzo mainstream, e questo sarebbe già sufficiente a porlo su un piedistallo. Forse questa sua capacità di scavare nell’animo dei personaggi non è funzionale al ritmo a cui siamo abituati in un testo thrilling, noir, giallo o come lo si voglia battezzare, sta di fatto che i personaggi di Connolly non si dimenticano appena dopo aver letto l’ultima pagina come di solito accade per quelli di questo genere di romanzi. Quanto appena scritto, naturalmente, può essere percepito come un pregio o un difetto a seconda della sensibilità letteraria di ognuno, ma di certo è una peculiarità molto rara.
Credo che molto dipenda dal suo approccio alla scrittura. In alcune occasioni si ha la sensazione che Connolly, a dispetto di quanto “prescritto” dal manuale del bravo giallista, fermi l’azione, la blocchi e divaghi dalla vicenda in senso stretto per prendersi una pausa, come se volesse affermare il suo diritto di essere uno scrittore e non un forzato del voltapagina. Anche lui usa i cliffhanger, ma lo fa con soavità e con tecnica molta diversa da quella che si è soliti incontrare nei gialli. Spesso alla “costrizione” a girar pagina segue una divagazione che allenta la tensione, che lascia il lettore spaesato, in una sorta di coito interrotto con l’intreccio. Ai puristi del giallo, che probabilmente hanno un’idea un pochino ristretta su ciò che dev’essere un romanzo, certe licenze possono risultare fastidiose, come sgraditi potrebbero risultare gli sconfinamenti nel paranormale, nell’affacciarsi di presenze non reali, ma io sono convinto che quest’atteggiamento compositivo sia un arricchimento e non una tara.
Come sempre non farò cenno alla trama e ai suoi sviluppi, molto più importante del dire di un rapimento mi sembra il cercare di far capire come lo si scrive, come lo si pensa letterariamente e in questo caso la forma che ha scelto Connolly mi sembra molto interessante, sicuramente non consueta e non aggressiva verso il lettore che ha la possibilità di godere della vicenda e, soprattutto, del modo di raccontarla.
Andrea Camilleri. La giostra degli scambi Sellerio editore, 2015. 257 pag. 14 euro.
 Escludendo gli “arancini”, i Montalbani giovanili e tutte le altre frattaglie che hanno segnato la strada del fenomeno narrativo e televisivo legato al commissario Montalbano, questo (se non ho contato male) è il ventitreesimo romanzo che vede protagonista il poliziotto di Vigata. Da interviste rilasciate da Camilleri pare certo che molti altri romanzi siano già stati completati e siano pronti per la stampa, compreso quello in cui Montalbano passerà a miglior vita.
Escludendo gli “arancini”, i Montalbani giovanili e tutte le altre frattaglie che hanno segnato la strada del fenomeno narrativo e televisivo legato al commissario Montalbano, questo (se non ho contato male) è il ventitreesimo romanzo che vede protagonista il poliziotto di Vigata. Da interviste rilasciate da Camilleri pare certo che molti altri romanzi siano già stati completati e siano pronti per la stampa, compreso quello in cui Montalbano passerà a miglior vita.
Sempre da altre interviste sembra di capire che la pubblicazione dell’ultimo atto seguirà la morte dell’autore per un fatto puramente scaramantico. In una cena a tre con M. Vasquez Montalban ( il papà di Pepe Carvalho, a cui il commissario siciliano deve il suo nome) e J.C. Izzo (il papà del commissario Montale protagonista della trilogia di Marsiglia) Camilleri seppe che entrambi i suoi colleghi avevano deciso di far morire i loro poliziotti nel successivo romanzo e, visto che la vita anticipò la fantasia uccidendo i due scrittori, l’autore siciliano ha deciso di far vivere una vita molto lunga al suo protagonista.
Questo è utile a capire come certe scelte vengano dettate da elementi che poco o nulla hanno a che vedere con l’urgenza narrativa e/o il sacro fuoco dell’ispirazione letteraria, e che ormai la produzione letteraria dell’ultraottantenne Camilleri ha ben poco da condividere con la voglia di comunicare, qualsiasi accezione del verbo si voglia adottare. Ad onore dell’anziano scrittore (io scrivo anziano per gentilezza ma sono certo che lui preferirebbe la parola “vecchio”) va detto che alla domanda sui motivi che lo spingessero a continuare questa saga infinita, la risposta fu: “Sa quanti posti di lavoro tengo in piedi continuando a scrivere i romanzi di Montalbano?”
Questa risposta ci fa capire cosa abbiamo davanti quando in libreria vediamo la copertina di un nuovo Montalbano: quello che abbiamo di fronte è un purissimo prodotto industriale, niente di più e niente di meno. Per correttezza Sellerio dovrebbe stampare sul retro l’elenco degli ingredienti, come nei prodotti alimentari. Passeggiate sul molo: 3. Telefonate notturne con Livia: 4 Strafalcioni di Catarella: 7, Riflessioni sull’avanzare dell’età: 5. Pranzi alla trattoria di fiducia: 6, ecc. ecc.
D’altro canto la serialità è soprattutto questo, non c’è dubbio. Il lettore è rassicurato dalla ripetizione e l’autore evita di spremersi il cervello per creare nuovi personaggi, nuovi ambienti, nuove atmosfere e nuovi modi per esprimersi: il cerchio è perfettamente chiuso.
Non credo che questo sia il modo migliore di promuovere e diffondere la narrativa, ma se questo dovesse servire a incassare denaro per rischiare su autori esordienti od emergenti sarei perfettamente d’accordo sulla politica adottata. Più o meno questo accadeva nel cinema degli anni settanta, quando filmacci pseudo sexy, disgustosi pierini e “monnezze” di vario tipo e misura servivano a far soldi per finanziare i film d’arte dei grandi registi regolarmente snobbati dal grande pubblico.
Me ne rendo conto, ho notevolmente divagato e ho parlato poco o nulla di questo ventitreesimo episodio, d’altro canto cosa posso dire che non sia già stato detto? Posso concludere riprendendo quanto scritto qualche riga fa, nient’altro.
“La giostra degli scambi” è un mero prodotto industriale, in cui ogni asperità è smussata e levigata fino a scomparire, ogni novità è bandita e perseguita come un odioso crimine e tutto è reso prevedibile con un accanimento che rasenta il sadismo. Tutto questo non causerà di certo un calo delle vendite, ne sono certo, è anzi probabile che saranno le cause di un ulteriore successo editoriale, ma non voglio sembrare uno snob e etichettare tutto questo con parole vigliacche e denigratorie, basta guardarsi un attimo attorno per capire che la narrativa è soltanto uno dei campi da gioco in cui valgono queste regole.
I panini di Mc Donald’s hanno cambiato gusto?
Il festival di Sanremo è stato meno visto negli ultimi trent’anni?
Baglioni e Morandi in tour vi sembrano innovativi?
I teatri “importanti” hanno smesso di programmare a rotazione le stesse “piece” di trent’anni o cinquant’anni fa?
Rubrica a cura di Daniele Borghi


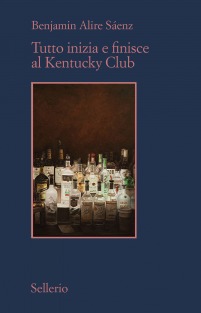


Fantastico il libro di racconti di Ritchie! Di suo ti consiglio anche “È ricca, la sposo e l’ammazzo”, sì proprio lo stesso titolo del film con Walter Matthau, film tratto proprio da un racconto di Jack Ritchie. Tornando a “Un metro quadrato di Texas” ha visto la curiosa teoria sull’identità di Jack lo Squartatore? 😉