A volte ritorno. John Niven – Einaudi, 2012. 390 pag. 19 euro.





 Il titolo originale di questo romanzo, “The second coming”, è molto più appropriato di quello italiano, sembra sia una consuetudine che gli editori italiani, come i distributori cinematografici, si adoperino con grande impegno a peggiorare quanto arriva a loro dall’estero. A dispetto di questi tentativi, il racconto della “seconda volta” di Gesù Cristo sulla terra è ordito e tornito in maniera deliziosa e va sottolineato che, di fronte ad una tematica come questa, non era un’impresa facile. Le trappole sulla strada imboccata da Niven erano moltissime e tutte decisamente insidiose, ma l’autore è riuscito ad evitarle con grande destrezza. Il romanzo, volendolo schematizzare piuttosto rozzamente, si può dividere in tre parti, sensibilmente diverse tra loro sia per tematica che per scrittura. Le prima sessanta pagine sono di puro divertimento e la loro estrema sintesi è questa: Dio torna da una vacanza di quattrocento anni (dei nostri, per lui sono una settimana di pesca alla trota) e trova un mondo che non somiglia per nulla a quello del Rinascimento. E’ decisamente una brutta sorpresa, ma la cosa che più diverte è vederne le reazioni, le riflessioni, iniziare a scoprirne la personalità e coglierne il sincero stupore davanti alle bestialità degli esseri umani. Non riesce a rassegnarsi per tutto ciò che è stato fatto in suo nome. Le sue considerazioni su come l’umanità abbia tradito il suo unico vero comandamento (“Fate i bravi”) sono veramente molto divertenti, a tratti esilaranti. Come a suo tempo ci raccontano che accadde, per cercare di dare una sistematina alle cose, decide di mandare sulla terra il suo unico figlio. La parte centrale, la narrazione della vera e propria “seconda venuta”, ci racconta dell’avventura terrena di Gesù. La nuova incarnazione di Cristo è un rocker indie tra i più sfigati della storia della letteratura, e Niven ce la propone con un tono neutro, a volte lievemente didascalico anche se spesso divertente.
Il titolo originale di questo romanzo, “The second coming”, è molto più appropriato di quello italiano, sembra sia una consuetudine che gli editori italiani, come i distributori cinematografici, si adoperino con grande impegno a peggiorare quanto arriva a loro dall’estero. A dispetto di questi tentativi, il racconto della “seconda volta” di Gesù Cristo sulla terra è ordito e tornito in maniera deliziosa e va sottolineato che, di fronte ad una tematica come questa, non era un’impresa facile. Le trappole sulla strada imboccata da Niven erano moltissime e tutte decisamente insidiose, ma l’autore è riuscito ad evitarle con grande destrezza. Il romanzo, volendolo schematizzare piuttosto rozzamente, si può dividere in tre parti, sensibilmente diverse tra loro sia per tematica che per scrittura. Le prima sessanta pagine sono di puro divertimento e la loro estrema sintesi è questa: Dio torna da una vacanza di quattrocento anni (dei nostri, per lui sono una settimana di pesca alla trota) e trova un mondo che non somiglia per nulla a quello del Rinascimento. E’ decisamente una brutta sorpresa, ma la cosa che più diverte è vederne le reazioni, le riflessioni, iniziare a scoprirne la personalità e coglierne il sincero stupore davanti alle bestialità degli esseri umani. Non riesce a rassegnarsi per tutto ciò che è stato fatto in suo nome. Le sue considerazioni su come l’umanità abbia tradito il suo unico vero comandamento (“Fate i bravi”) sono veramente molto divertenti, a tratti esilaranti. Come a suo tempo ci raccontano che accadde, per cercare di dare una sistematina alle cose, decide di mandare sulla terra il suo unico figlio. La parte centrale, la narrazione della vera e propria “seconda venuta”, ci racconta dell’avventura terrena di Gesù. La nuova incarnazione di Cristo è un rocker indie tra i più sfigati della storia della letteratura, e Niven ce la propone con un tono neutro, a volte lievemente didascalico anche se spesso divertente.
La terza, la più breve delle tre, animata da uno spirito che, in alcuni brani, non ho reticenze a definire lirico, ci narra di come Gesù venga riaccolto in paradiso e come lui stesso si accinga a accogliere i suoi amici terreni.
“A volte ritorno” è un romanzo evidentemente surreale, scritto senza velleità letterarie e, in molti passaggi, divertentissimo, ma ciò che più colpisce favorevolmente è la capacità di affrontare argomenti per nulla lievi con una sorta di sorriso “letterario” e una leggerezza che mai, in nessun passaggio, somiglia alla superficialità. Il romanzo di John Niven, apparentemente dissacrante e quasi blasfemo, trasmette un senso di profonda umanità che rimane dentro a lungo. Credo dovrebbe essere letto da tutte le persone per cui un dio, uno qualsiasi, serve soltanto per usarne il nome a proprio vantaggio. Forse riuscirebbe a farle vergognare.
Identità rubate. T. Coraghessan Boyle – Einaudi, 2008. 392 pag. 22 euro





 Di T.C.B. ricordavo con piacere una raccolta di racconti di una dozzina di anni fa (“Se il fiume fosse whisky”) e ne ricordavo lo sguardo sghembo sull’affaccendarsi umano. Erano racconti che parlavano di umanità deficitaria per la società, non allineata, estranea al consueto. Per questo, quando ho visto questo romanzo su una bancarella me ne sono subito impossessato.
Di T.C.B. ricordavo con piacere una raccolta di racconti di una dozzina di anni fa (“Se il fiume fosse whisky”) e ne ricordavo lo sguardo sghembo sull’affaccendarsi umano. Erano racconti che parlavano di umanità deficitaria per la società, non allineata, estranea al consueto. Per questo, quando ho visto questo romanzo su una bancarella me ne sono subito impossessato.
Errore. Per fortuna costato pochi euro, ma errore. Nel romanzo non esiste traccia di nulla che non sia un tetro tentativo commerciale, un triste e mal riuscito thriller che non è un thriller ma solo uno strazio per chi legge. La minuziosità dei dettagli, le descrizioni, i dialoghi e i personaggi sembrano fatti apposta per irritare il lettore, per metterlo nella condizione di leggere esclusivamente per capire quanto sia mal riuscito il testo, fino a che punto l’autore abbia sbagliato strada e si ostini a percorrerla senza ripensamenti. Essere così severo con un autore che in passato ha mostrato capacità di scrittura di gran lunga migliori non è affatto piacevole, ma la certezza (scusate la presunzione) che questo romanzo sia stato scritto con il solo intento di inserirsi nel ricco mercato del “giallo/thriller” non mi lascia dubbi o ripensamenti. In due parole: da evitare.
Il capitale umano, Stephen Amidon – Oscar Mondadori, 2006. 415 pag. 9,40 euro
(Pidocchiosamente portato a 10 euro, quando è uscito il film, con un autoadesivo della Mondadori. Vergogna!)





 Non ho ancora visto il film di Virzì ispirato da questo romanzo, ma non è difficile intuire le ragioni che hanno spinto il regista toscano a trarne una sceneggiatura. Soltanto una sguardo superficiale e disattento potrebbe percepire distanti i due mondi, quello americano del testo e quello brianzolo del film. Il panorama interiore è probabilmente identico, desolatamente sovrapponibile. Questo per dire che ciò che mi accingo a scrivere nulla a che vedere con il film, ma soltanto con la qualità del romanzo che, per ciò che mi riguarda è molto lontana dall’essere soddisfacente. La scrittura è piatta e superficiale, ricchissima di inutili dettagli che appesantiscono la narrazione in maniera quasi insopportabile. Spesso si impiglia in uno schema di cui si vedono chiaramente i contorni i quali, alla lunga, diventano sempre più evidenti e fastidiosi. Il ripetersi dello schema è stucchevole: ogni capitolo inizia osservando un personaggio diverso da quello del precedente e raccontando, (spessissimo senza che ve ne sia alcuna ragione letteraria, di struttura o di trama) ciò che il nuovo protagonista ha fatto/detto nel periodo in cui lo abbiamo lasciato per seguire il precedente. Questo fa si che almeno un quarto del romanzo sia utile soltanto ad aumentare il numero delle pagine e il volume dello scroto del lettore. L’intreccio si può definire ben costruito, ma se ne avverte l’artificiosità, la vera e propria costruzione di ogni brano in funzione di dove l’autore vuole arrivare. I personaggi sono bidimensionali, senza profondità e assolutamente prevedibili in ogni azione o dialogo. Mai nulla che in tutta la lettura sorprenda e spinga per un momento a distogliere la vista dalla pagina per riflettere un istante. E poi, detto in tutta franchezza: c’era bisogno di un altro romanzo che parlasse degli “squali della finanza”, “dello squallore del denaro”, “della meschinità di chi vuol emulare i ricchi”?
Non ho ancora visto il film di Virzì ispirato da questo romanzo, ma non è difficile intuire le ragioni che hanno spinto il regista toscano a trarne una sceneggiatura. Soltanto una sguardo superficiale e disattento potrebbe percepire distanti i due mondi, quello americano del testo e quello brianzolo del film. Il panorama interiore è probabilmente identico, desolatamente sovrapponibile. Questo per dire che ciò che mi accingo a scrivere nulla a che vedere con il film, ma soltanto con la qualità del romanzo che, per ciò che mi riguarda è molto lontana dall’essere soddisfacente. La scrittura è piatta e superficiale, ricchissima di inutili dettagli che appesantiscono la narrazione in maniera quasi insopportabile. Spesso si impiglia in uno schema di cui si vedono chiaramente i contorni i quali, alla lunga, diventano sempre più evidenti e fastidiosi. Il ripetersi dello schema è stucchevole: ogni capitolo inizia osservando un personaggio diverso da quello del precedente e raccontando, (spessissimo senza che ve ne sia alcuna ragione letteraria, di struttura o di trama) ciò che il nuovo protagonista ha fatto/detto nel periodo in cui lo abbiamo lasciato per seguire il precedente. Questo fa si che almeno un quarto del romanzo sia utile soltanto ad aumentare il numero delle pagine e il volume dello scroto del lettore. L’intreccio si può definire ben costruito, ma se ne avverte l’artificiosità, la vera e propria costruzione di ogni brano in funzione di dove l’autore vuole arrivare. I personaggi sono bidimensionali, senza profondità e assolutamente prevedibili in ogni azione o dialogo. Mai nulla che in tutta la lettura sorprenda e spinga per un momento a distogliere la vista dalla pagina per riflettere un istante. E poi, detto in tutta franchezza: c’era bisogno di un altro romanzo che parlasse degli “squali della finanza”, “dello squallore del denaro”, “della meschinità di chi vuol emulare i ricchi”?
Francamente non credo. Sono arrivato al punto che se leggessi un romanzo in cui qualcuno che si occupa di finanza fosse descritto come una brava persona urlerei dalla felicità. Ma queste sono riflessioni molto personali, forse superflue. Anche qui, in sintesi: un prodotto in cui si vede e si sente la mano dell’industria editoriale, di un editing ossessivo e, per certi versi, dequalificante e spersonalizzante, come la copia di un Caravaggio fatta a riga e squadra. I romanzi che vengono dal profondo sono di tutt’altra pasta. A volte contengono errori, ridondanze, sviste e lacune, ma sono proprio questi elementi a costituirne l’identità, come un piccolo difetto su un volto affascinante.
I tre demoni John Connolly – Fanucci. 442 pag. 5,90 euro.





 Ho letto molti altri romanzi di Connolly e, pur non reputandolo un genio, li ho spesso trovati piacevolmente misteriosi, per certi versi affascinanti. Questi precedenti e il meritevole prezzo da saldo di quest’ultimo mi hanno convinto all’acquisto. Purtroppo il sapore che lascia in bocca quest’ultima opera non è quello delle precedenti. Si ha la sensazione di mangiare un piatto dai troppi ingredienti diversi e, in alcuni casi, che bisticciano tra loro.
Ho letto molti altri romanzi di Connolly e, pur non reputandolo un genio, li ho spesso trovati piacevolmente misteriosi, per certi versi affascinanti. Questi precedenti e il meritevole prezzo da saldo di quest’ultimo mi hanno convinto all’acquisto. Purtroppo il sapore che lascia in bocca quest’ultima opera non è quello delle precedenti. Si ha la sensazione di mangiare un piatto dai troppi ingredienti diversi e, in alcuni casi, che bisticciano tra loro.
Connolly affronta temi spietatamente concreti come la sindrome post traumatica da stress che colpisce i militari americani al ritorno da Iraq e Iran, dimostrando di essersi puntigliosamente documentato al riguardo e li intreccia con aspetti soprannaturali del tutto campati in aria e che non riescono a pervadere sottilmente la scrittura come era avvenuto in passato, riuscendo solo a pasticciare. E questo è soltanto uno dei molti esempi che si potrebbero fare, ma non voglio dilungarmi perché sarebbero una sorta di elenco noioso. Stavolta, purtroppo per lui e per noi lettori, la miscela non è riuscita bene.
I suoi due mondi narrativi (quello strettamente legato alla detective story) e quello soprannaturale (popolato dai fantasmi della moglie e della figlia, dal Male, e dal Demonio, che qui sembra rappresentato da una figura indefinita chiamata “il capitano”) non riescono a fondersi e nel momento in cui vengono a contatto si avverte una certa rigidità di schema e non un felice fluire.
Non si può assolutamente dire che il romanzo sia sgradevole, ma di certo non è riuscito al meglio. Alcuni personaggi sembrano più stereotipi di genere che invenzioni letterarie e la griglia del plot a volte sembra schiantarsi sotto il peso della carne che Connolly vuol farci cuocere sopra. Spero che Connolly, dopo questo mezzo passo falso, torni a scrivere senza voler per forza inserire nella trama tutto quello che gli sembra utile a darle corpo e mistero, ma soltanto quello che sente di narrare con sincerità.
Il desiderio di essere come tutti. Francesco Piccolo – Einaudi, 2013. 272 pag. 18 euro.





 La goffa presentazione televisiva di questo testo fatta a “Che tempo che fa”, un luogo televisivo che da tempo ha la capacità di innervosirmi (ma questo è tutt’altro argomento) e di cui Piccolo stesso è uno degli autori, mi aveva lasciato una specie di nodo in testa. Il primo grumo di corda è stata una domanda: dopo Gramellini (romanzo sulla mamma suicida campione di vendite. Il libro, non la mamma) e Serra (“Gli sdraiati”), i vari libri (?) della Littizzetto, autori o ospiti fissi del programma, dopo tante prediche sul conflitto d’interessi e sull’uso privato o privatistico della televisione pubblica, non è che per caso ci stanno coglionando e hanno imparato come si fa? Potrei andare avanti per molto con domande di questo tenore e anche di altri, ma non ho moltissimo spazio e voglio arrivare ad una specie di conclusione. Tutte le risposte, riflettendoci, sono arrivate dalla stessa goffaggine di Piccolo. Non sembrava a proprio agio, non riusciva a mettere a fuoco un percorso per appunto presentarci il suo libro e sembrava avesse voluto essere da molte parti, ma non davanti alle telecamere. Mi sono risposto in due modi, di cui uno non esclude l’altro. Il primo: si è reso conto del cosiddetto conflitto di interessi (in pratica si è autoinvitato a autopromuoversi). Il secondo: il libro non poteva essere riassunto e condensato in qualche battuta. Lo so ho fatto un preambolo troppo lungo, però mi sembrava doveroso perché è stata proprio questa incertezza a spingermi a leggere questo lavoro. E il fatto che, all’inizio, non fossi convintissimo della scelta, sta a significare che, talvolta, (anzi, quasi sempre) i pregiudizi è meglio metterseli, come diceva qualcuno che non è più su questa terra, in “der posto”.
La goffa presentazione televisiva di questo testo fatta a “Che tempo che fa”, un luogo televisivo che da tempo ha la capacità di innervosirmi (ma questo è tutt’altro argomento) e di cui Piccolo stesso è uno degli autori, mi aveva lasciato una specie di nodo in testa. Il primo grumo di corda è stata una domanda: dopo Gramellini (romanzo sulla mamma suicida campione di vendite. Il libro, non la mamma) e Serra (“Gli sdraiati”), i vari libri (?) della Littizzetto, autori o ospiti fissi del programma, dopo tante prediche sul conflitto d’interessi e sull’uso privato o privatistico della televisione pubblica, non è che per caso ci stanno coglionando e hanno imparato come si fa? Potrei andare avanti per molto con domande di questo tenore e anche di altri, ma non ho moltissimo spazio e voglio arrivare ad una specie di conclusione. Tutte le risposte, riflettendoci, sono arrivate dalla stessa goffaggine di Piccolo. Non sembrava a proprio agio, non riusciva a mettere a fuoco un percorso per appunto presentarci il suo libro e sembrava avesse voluto essere da molte parti, ma non davanti alle telecamere. Mi sono risposto in due modi, di cui uno non esclude l’altro. Il primo: si è reso conto del cosiddetto conflitto di interessi (in pratica si è autoinvitato a autopromuoversi). Il secondo: il libro non poteva essere riassunto e condensato in qualche battuta. Lo so ho fatto un preambolo troppo lungo, però mi sembrava doveroso perché è stata proprio questa incertezza a spingermi a leggere questo lavoro. E il fatto che, all’inizio, non fossi convintissimo della scelta, sta a significare che, talvolta, (anzi, quasi sempre) i pregiudizi è meglio metterseli, come diceva qualcuno che non è più su questa terra, in “der posto”.
“Il desiderio di essere come tutti” ha un solo difetto: come inevitabilmente accade ad un libro con ampie possibilità di vendita ha dovuto subire un’orribile quarta di copertina, più o meno la stessa sorte capitata a “Joshua” di Richler. Sia in sede di presentazione che, appunto, sulla quarta, è stata ripetuta la cosa meno intelligente di tutto il testo: “Il 22 giugno 1974, al 78° minuto di una partita di calcio, sono diventato comunista”. Questa frase, decontestualizzandola, sembra una battuta da Bagaglino, ridicolizzante, quasi da scemo del paese.
Per fortuna ho superato anche questi ostacoli e ho comprato e letto questo libro. Continuo a non usare la parola romanzo, scrivendo testo, lavoro o libro, perché di romanzo nel senso stretto del termine non si trova assolutamente nulla. Nessun personaggio inventato, nessuna situazione creata e neppure “romanzata”, ma soltanto il percorso di una vita trascorsa a sinistra. Non sono certo di essere obiettivo e, tutto sommato, non me ne frega molto, ma devo dire che raramente sono stato toccato così profondamente da un testo. Sarà perché ho un percorso condiviso con Piccolo e che, avendolo percepito estremamente sincero, ne sento la vicinanza anche da un punto di vista umano, intimo, ma nessun altro lavoro che io abbia letto è riuscito a far meglio luce sul popolo della sinistra italiana e a raccontare come questo popolo abbia vissuto gli ultimi decenni, dalla strage di via Fani in poi. Ora capisco il disagio di Piccolo davanti alle telecamere: un testo come questo non può essere riassunto o promosso con qualche frase ad effetto. Il tema è troppo complesso e articolato per poter togliere anche una sola parola a tutto quello che ha scritto. Non poteva farlo meglio, con più sincerità e con maggiore chiarezza e felicità di scrittura. Aggiungere altro sarebbe fare un torto all’autore violentando il suo lavoro e costringendolo ad una sintesi che non ha ragione di esistere.
L’argomento che ha trattato con così grande intelligenza non è cosa che mi possa permettere di liquidare in poche righe e, tantomeno, avere la presunzione di riuscire a farlo compiutamente. Le problematiche complesse hanno necessità di risposte articolate. Spesso la sinistra, i suoi intellettuali organici e spesso anche i suoi militanti, sono stati accusati di essere prolissi e poco concreti, di eccedere nell’analisi e non giungere mai ad una sintesi. Probabilmente in quest’accusa c’è del vero, ma in questo testo analisi e sintesi sono perfettamente misurate, partecipate ed equilibrate, inattaccabili e precise come un puntatore laser. E tutto questo non attraverso la freddezza di un saggio con stupide pretese di obiettività, ma con una partecipazione emotiva profonda, senza risparmio di autocritica e senza la macchinosa costruzione di concetti e tesi da dimostrare con la scrittura. Piccolo non è Proust e, fossi in lui, ne sarei orgoglioso.
Non voglio scrivere altro, spero vogliate leggere questo libro.
recensioni di Daniele Borghi
Daniele Borghi


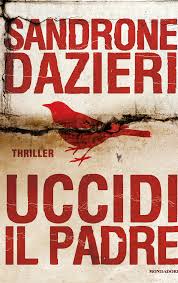
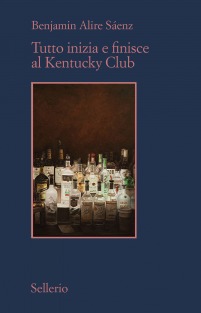

…toh… mi hai convinto…anche se non hai detto niente. Visto!