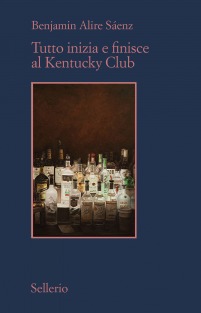Jean Cristophe Rufin, Check Point Edizioni E/O, 2015. 298 pag. 18 euro
Traduzione: Alberto Bracci Testasecca





 Ai francesi questo romanzo è piaciuto tantissimo, sia a livello di critica che a livello di vendite. Per come la vedo io, è pressoché certo che questo successo sia esclusivamente dovuto alla fama dell’autore, il fondatore di Medici senza Frontiere e alla sua aura di santità ormai consolidata. Tanto per fare un parallelo: è come se in Italia Gino Strada pubblicasse un romanzo sull’attività dei suoi ospedali sparsi per i quattro angoli più sfortunati del mondo e mettesse addosso ai personaggi le inevitabili (per non dire ovvie e scontatissime) contraddizioni che certe situazioni portano a galla. Chi avrebbe il coraggio di dire che il testo è una sontuosa cagata e gli consiglierebbe di continuare a fare soltanto il medico? Penso davvero in pochi. E se ci fosse qualcuno con il coraggio di farlo si potrebbe star certi che verrebbe lapidato dopo un breve e sommario processo culturalpolitico.
Ai francesi questo romanzo è piaciuto tantissimo, sia a livello di critica che a livello di vendite. Per come la vedo io, è pressoché certo che questo successo sia esclusivamente dovuto alla fama dell’autore, il fondatore di Medici senza Frontiere e alla sua aura di santità ormai consolidata. Tanto per fare un parallelo: è come se in Italia Gino Strada pubblicasse un romanzo sull’attività dei suoi ospedali sparsi per i quattro angoli più sfortunati del mondo e mettesse addosso ai personaggi le inevitabili (per non dire ovvie e scontatissime) contraddizioni che certe situazioni portano a galla. Chi avrebbe il coraggio di dire che il testo è una sontuosa cagata e gli consiglierebbe di continuare a fare soltanto il medico? Penso davvero in pochi. E se ci fosse qualcuno con il coraggio di farlo si potrebbe star certi che verrebbe lapidato dopo un breve e sommario processo culturalpolitico.
Non è per fare l’eroe o il bastian contrario, è che proprio non riesco a tenermelo dentro. Mi sembra di essere Fantozzi alla sessantesima visione de “La corazzata Potemkin” e come lui non resisto: “Check point” è una cagata pazzesca. Ecco, l’ho detto.
Questo medico sedicente romanziere non ha il minimo talento, e probabilmente se il talento fosse un articolo in vendita non saprebbe neppure dove andare a comprarlo perché non sarebbe in grado di riconoscerlo. Riesce a rendere noiosa in modo assillante una vicenda che con un minimo di dimestichezza con la narrativa sarebbe stata avvincente. E’ capace di mettere nero su bianco parole come “amplesso” e di infilare nella storia ragazze (nota bene: abitanti in una grande città francese, non nella Terra del Fuoco o in Groenlandia), che perdono la verginità a ventidue anni travolte dal fascino tenebroso e virile di ex militari. Santoddio, ma come si può pretendere che nel 2015 si ingoi tutto questo senza smorfie di disgusto?
Alla fine del romanzo, non contento di averci infelicitato più che troppo, ci ammorba con ulteriori sei pagine di un surreale monologo in cui ci racconta perché ha scelto quel titolo, quali sono state le sue intenzioni narrative, le scelte linguistiche e tutto l’ambaradan che compone un testo. Praticamente si è fatto da solo una intervista senza domande, mancava poco che si desse anche una valutazione critica e un bel nove in pagella. Con lui Marzullo andrebbe a nozze.
Jean Cristophe, facci un favore: torna a organizzare missioni umanitarie e a curare i malati, la sanità ha bisogno di te. La narrativa che sparisci.
Brendan O’ Carroll, Agnes Brown nonna Beat Edizioni, 2015 (1996).191 pag. 9 euro
Traduzione: Gaja Cenciarelli





 Probabilmente se avessi letto questo romanzo quando è uscito per la prima volta in Irlanda, circa vent’anni fa, ne avrei ricevuto un’altra impressione e avrei potuto trarre un minimo piacere dalla sua lettura. Il guaio è che, arrivando con vent’anni di ritardo, molte delle situazioni e delle atmosfere che si respirano pagano dazio nel giungere ora, quando tutta la narrativa irlandese (e non solo) ha reso luoghi comuni la liturgia del pub, la conflittualità familiare originata dai temperamenti bellicosi e incendiari, la visione sacrale dell’amicizia ecc. ecc.
Probabilmente se avessi letto questo romanzo quando è uscito per la prima volta in Irlanda, circa vent’anni fa, ne avrei ricevuto un’altra impressione e avrei potuto trarre un minimo piacere dalla sua lettura. Il guaio è che, arrivando con vent’anni di ritardo, molte delle situazioni e delle atmosfere che si respirano pagano dazio nel giungere ora, quando tutta la narrativa irlandese (e non solo) ha reso luoghi comuni la liturgia del pub, la conflittualità familiare originata dai temperamenti bellicosi e incendiari, la visione sacrale dell’amicizia ecc. ecc.
A questo repertorio, che ormai non mostra più soltanto un semplice logoramento ma che sta andando verso la autoconsunzione, va aggiunta una scrittura non brillante e una struttura per certi versi scontata e per altri ruffiana. Quasi tutto il romanzo, più che strizzare l’occhio al lettore meno smaliziato fa altre cose, ad esempio usare la lingua in zone umide e ombrose. Questa volontà di leccaculismo, di impegno a mai carezzare contropelo il lettore, si percepisce con irrisoria facilità nell’avanzare nella lettura e da tre quarti in poi ci si stupisce che la volontà dell’autore di solleticare i sentimenti più basici dell’animo umano, sia così spiattellata su pagina senza che l’autore stesso ne provi vergogna. Uno dei fili principali della trama, la vicenda di un giovane scapestrato che uccide involontariamente una persona, che si fa i suoi anni di carcere, litiga con la madre e poi, una volta fuori, diventa un ricco scrittore di successo e va in visita riconciliatoria alla madre un attimo prima che quest’ultima muoia è pacchiana e ruffiana in un modo spaventoso. Forse neppure una fiction di Rai 1 riuscirà ad arrivare a tanto. Oltre a questo, e forse da un punto di vista letterario è questo il fatto più grave, è che l’autore non riesce mai a cambiar passo, a dare voce e suono diversi in situazioni dal pathos opposto.
La piattezza è spesso imbarazzante, l’attenzione alla calibratura della narrazione è inesistente.
Ci sarebbe da farsi un sacco di domande ma io , pietosamente, le risparmio al lettore, in fondo non credo servano le mie considerazioni per capire lo stato in cui si trova quella che una volta veniva chiamata industria culturale. Adesso non saprei neppure come chiamarla: non fa industria ( le case editrici non hanno neppure un residuo di pantaloni su cui piazzare le toppe sulle chiappe) e, non fa cultura perché quello che quasi sempre vogliono propinarci è tutto meno che cultura, quando va bene, ma veramente molto bene, è buon intrattenimento.
Chissà se un giorno proveranno a farsi qualche domandina…
Massimo Carlotto, Per tutto l’oro del mondo Edizioni E/O, 2015. 188 pag. 15 euro





 Più o meno un paio di decenni fa, quando la narrativa noir italiana iniziò a dare frutti buoni e maturi, essa veniva “usata” per dire cose che il giornalismo non poteva affermare perché ne avrebbe subito conseguenze legali. Con il banale escamotage “ogni riferimento a fatti realmente accaduti o a persone esistenti è puramente casuale”, i pionieri del nuovo giallo italiano mettevano su pagina le situazioni più tristi e oscure del nostro paese senza darsi troppo da fare per mascherarle.
Più o meno un paio di decenni fa, quando la narrativa noir italiana iniziò a dare frutti buoni e maturi, essa veniva “usata” per dire cose che il giornalismo non poteva affermare perché ne avrebbe subito conseguenze legali. Con il banale escamotage “ogni riferimento a fatti realmente accaduti o a persone esistenti è puramente casuale”, i pionieri del nuovo giallo italiano mettevano su pagina le situazioni più tristi e oscure del nostro paese senza darsi troppo da fare per mascherarle.
Ad esempio, proprio Carlotto, scrisse un noir dal titolo “Nessuna cortesia all’uscita” che narrava del “pentimento” di uno dei più feroci malavitosi degli ultimi decenni, quel Felice Maniero che fece molto parlare di sé e della sua spietata crudeltà, prima come boss della cosiddetta mafia del Brenta e poi come “pentito”. Il gioco era talmente scoperto ed evidente che il protagonista del testo di Carlotto si chiamava Tristano Castelli, usando un giochino di parole facilmente interpretabile anche da un bambino di sei anni. Questo è soltanto uno dei moltissimi esempi che si potrebbero fare, si potrebbe dire che ogni “mistero” della nostri storia recente sia stato trasposto in narrativa, dalle stragi di stato all’immenso casino del G8 di Genova.
Ora sembra che quel tempo sia finito e questo romanzo di Carlotto pare darne conferma. I fatti di cronaca sono diventati spunto, pretesto, una scintilla che innesca un processo produttivo/narrativo e non più un contesto da indagare. Non che questo dia luogo a romanzi scarsi o inutili, sempre questo romanzo ne l’esatta misura, ma l’impeto degli anni trascorsi è evaporato e nulla delle antiche intenzioni è rimasto. In “Per tutto l’oro del mondo” l’aggancio con la cronaca sono le rapine in villa, un argomento forse più da Tg4 che da Carlotto, ma tant’è. L’autore costruisce una articolatissima vicenda di tradimenti, omicidi e vendette ma anche l’esposizione sembra risentire di una certa mollezza e, in alcuni passaggi, di una ripetitività che nuoce all’insieme.
Oltre a questo, l’inserimento di vicende personali/sentimentali, atteggiamento narrativo tipico di chi non ha una storia centrale robusta e compiuta, ne interrompono il ritmo e, in alcuni passaggi, invece di arrotondare il personaggio, fanno apparire il protagonista e voce narrante come un lagnoso rincoglionito.
Tutto il resto è Carlotto a denominazione di origine controllata e garantita, nel bene (molto) e nel male (poco) che si può dire su quest’autore. Volendo riassumere il tutto in poche parole si potrebbe dire che questo romanzo tiene fin quando non ci si ricorda di quanto ha saputo dare il suo autore in altre prove, se quel pensiero assale l’insieme appare lievemente scipito e senza una direzione precisa che non sia quella di vendere libri.
Roger Hobbs, Pronti a svanire Einaudi, 2015. 345 pag. 19 euro
Traduzione: Alfredo Colitto





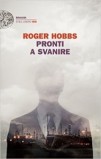 “Pronti a svanire” è un tipico giallaccio di azione senza punti morti e dal ritmo indiavolato. Con un vocabolario basico e uno “stile” senza nessun tipo di particolarità, narra di un mondo parallelo e nascosto che probabilmente esiste davvero: l’universo dei criminali di altissimo livello, dei ladri di fortune immense, ipertecnologici, superscaltri e ultraintelligenti.
“Pronti a svanire” è un tipico giallaccio di azione senza punti morti e dal ritmo indiavolato. Con un vocabolario basico e uno “stile” senza nessun tipo di particolarità, narra di un mondo parallelo e nascosto che probabilmente esiste davvero: l’universo dei criminali di altissimo livello, dei ladri di fortune immense, ipertecnologici, superscaltri e ultraintelligenti.
Come è facile notare anche dagli aggettivi iperbolici che ho usato, il romanzo si regge sulla solida convinzione che il lettore riesca a inghiottire di tutto, persino una macroscopica incongruenza da cui nasce l’intera vicenda. Infatti, dopo un inizio molto interessante e originale, in cui l’autore fa passare il testimone dell’io narrante da un personaggio all’altro (per essere più precisi da un personaggio al suo assassino in due occasioni) tutto il resto della narrazione prende spunto da un avvenimento che non ha la minima credibilità.
Fatta eccezione per questo non secondario particolare, il romanzo corre come un treno senza freni e senza stazioni in cui rallentare, lasciando – temo scientemente – poco tempo al lettore per rendersi conto di quanto siano improbabili le acrobazie dei due personaggi principali.
Certo, occorre abilità anche per fare questo, e gli affezionati al genere da voltapagina compulsivo non avranno di che lamentarsi, ma alla fine, quando tutto si acquieta e si ripone il volume nella libreria, la domanda che abita le circonvoluzioni del cervello è esattamente questa:
“Ma che cazzo ho letto?”.
Joe R. Lansdale. Honky Tonk Samurai Einaudi, 2015. 425 pag. 19,50 euro
Traduzione: Luca Briasco





 E finalmente ecco qui la nuova avventura di Hap e Leonard.
E finalmente ecco qui la nuova avventura di Hap e Leonard.
Fa sempre piacere ritrovarli in libreria, è come incontrare un vecchio amico che si è perso di vista per le imperscrutabili svolte della vita e del tempo e che, per caso, in un pomeriggio di solitudine, si incrocia per strada. Ci si informa delle ultime vicende, ci si chiede come stanno parenti e amici comuni e ci si lascia con la promessa, poi mai mantenuta, di rivedersi al più presto, magari anche con le famiglie. Come dicevo prima, fa piacere, a volte anche molto, ma è ben diverso da un incontro folgorante, un incontro che apre prospettive e orizzonti da esplorare in futuro. Ecco, quest’ultima avventura di Hap e Leonard è esattamente questo: non ci si può aspettare null’altro che qualcosa che già si conosce bene. Si ride, si sorride, si consolidano le conoscenze e si assorbono gli aggiornamenti, i nuovi acciacchi dovuti all’età che avanza, la tendenza a mettere su peso e a vedere i soliti problemi che non si risolvono mai del tutto.
Non ci si deve però attendere che l’incontro con questo romanzo abbia la stessa potenza deflagrante dei primissimi rendez-vous. Non è colpa di nessuno, tantomeno di Lansdale che, come quasi sempre gli accade, è in buonissima forma, se c’è qualcuno-qualcosa da accusare è l’abitudine del lettore agli schemi drammaturgici, alla monoliticità di alcuni personaggi e allo spirito che muove tutto il romanzo.
Sono certo che chi dovesse leggere questo testo come primo approccio al fantastico duo di pazzoidi che per tanti anni ci ha fatto compagnia, ne resterebbe affascinato e travolto, purtroppo per gli altri, per gli aficionados, non potrà essere così. Questo non vuol essere il requiem per Hap e Leonard, è soltanto la triste realtà di ogni serie, letteraria o televisiva che sia. Alla lunga non riesce più a portarti in un nuovo mondo: ci abiti già da tempo.
Rubrica a cura di Daniele Borghi